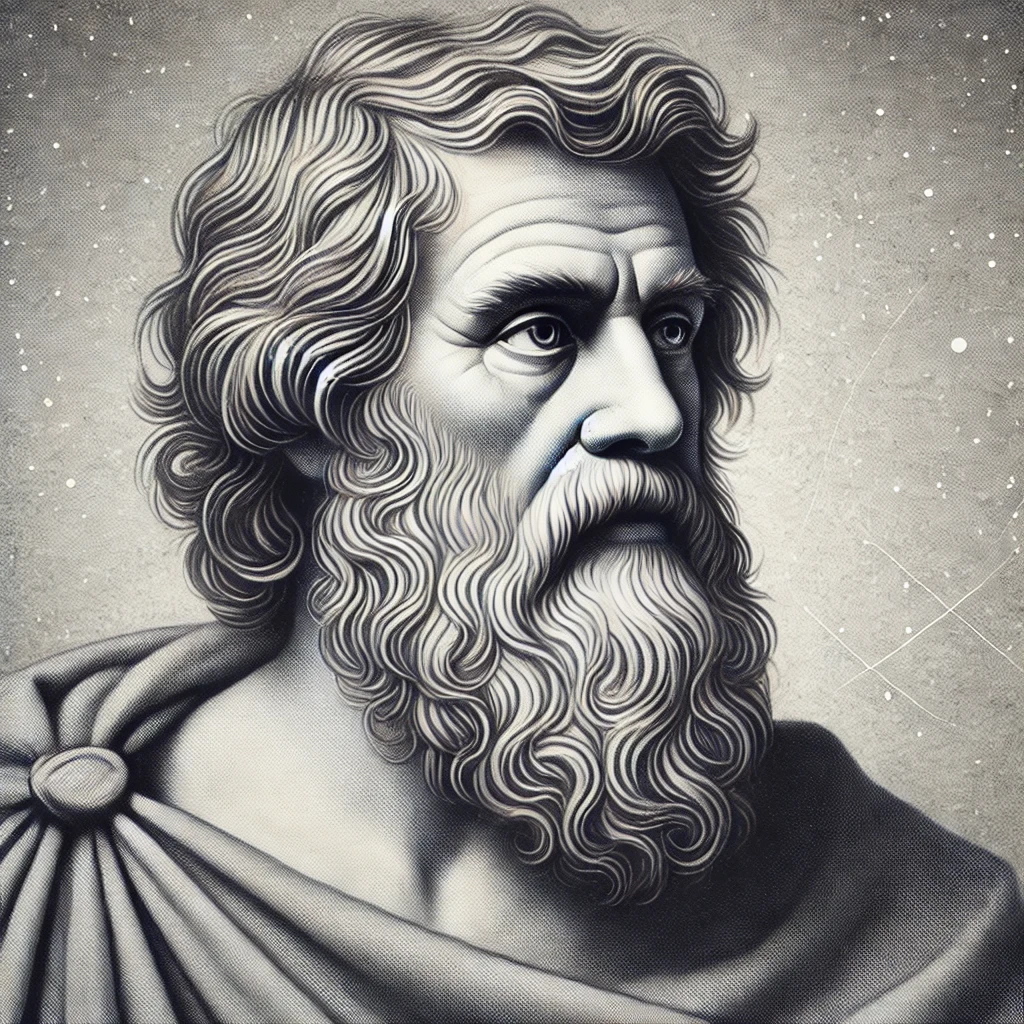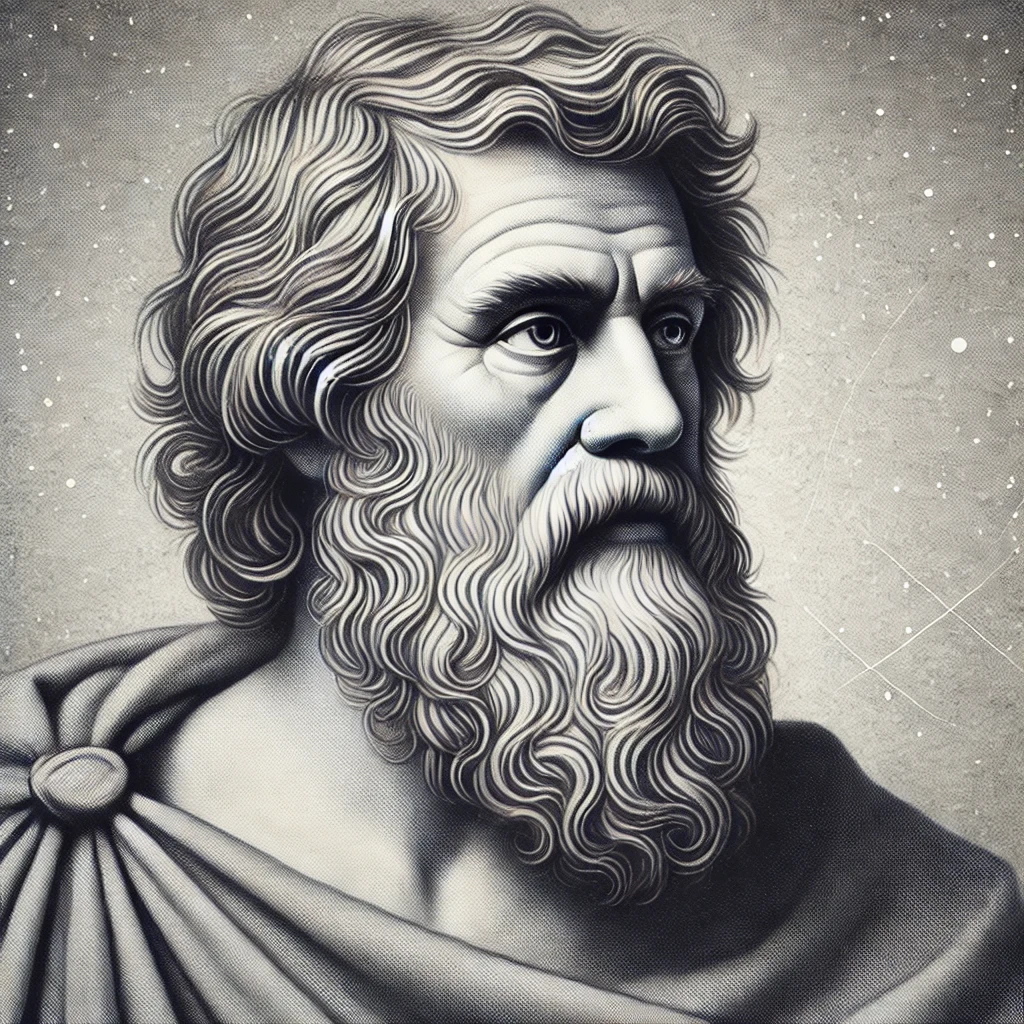
Anassagora, uno dei filosofi pluralisti, si distingue per il suo approccio empirico e per l’innovativa riflessione sull’archè e sul rapporto tra uomo e natura. Vissuto nel V secolo a.C., partecipa al fiorente circolo filosofico di Pericle ad Atene, centro del pensiero e della cultura nel secolo d’oro della classicità. Questo periodo, segnato dalla democrazia ateniese, trova una delle sue rappresentazioni più celebri nell’opera di Tucidide, La guerra del Peloponneso. Tucidide non si limita a narrare gli eventi, ma li analizza criticamente, ponendo le basi della storiografia scientifica.
SEMI E NOUS
Secondo Anassagora, l’archè non è unica, ma costituita da un’infinità di semi (σπέρματα, spérmata), particelle qualitativamente differenziate che formano ogni cosa. Inizialmente, i semi sono mescolati in uno stato caotico chiamato Migma (μίγμα, "mescolanza"). È il Nous (Νοῦς, "intelligenza") a ordinare il caos: questa forza divina, razionale e indipendente, separa e aggrega i semi per dar vita agli enti. Aristotele successivamente definirà questi semi come "omeomerie" (idὁμοιομέρειαι), particelle uguali tra loro che mantengono le stesse caratteristiche della materia che compongono (ad esempio, i semi dell’oro contengono sempre oro).La visione di Anassagora è rivoluzionaria per l’epoca: introduce l’idea di un’intelligenza che governa il cosmo in modo razionale, superando la concezione mitica e antropomorfica delle divinità.
GNOSEOLOGIA E LIBERTÀ INTELLETTUALE
Dal punto di vista gnoseologico, Anassagora sostiene che la conoscenza avviene per contrasti. Ad esempio, possiamo comprendere il concetto di “terra” solo in relazione a ciò che terra non è. Questa idea implica che la percezione e la comprensione si basano su opposizioni, un principio che anticipa alcune riflessioni della dialettica filosofica.Anassagora rappresenta un simbolo di libertà intellettuale. La sua riflessione critica e la sua tendenza a indagare razionalmente la realtà lo portano in conflitto con le credenze popolari e le tradizioni religiose. Viene processato per empietà e costretto all’esilio, evitando la condanna a morte grazie all’intercessione di Pericle. Questo episodio riflette il rischio che i filosofi correvano quando mettevano in discussione le strutture ideologiche che governavano la società.
Un aneddoto significativo riguarda l’arrivo di un indovino presso Pericle. Questi portò un montone con un’escrescenza sulla testa, sostenendo fosse un presagio di sventura perché era davanti alla casa di Pericle. Anassagora, presente al momento, confutò l’interpretazione dell’indovino spiegando che si trattava semplicemente di una malformazione biologica. Questo episodio illustra la differenza tra credere e conoscere: mentre la credenza si basa su interpretazioni irrazionali e serve a mantenere il controllo sociale, la conoscenza richiede indagine e spiegazioni razionali.
DIFFERENZA TRA UOMO E ANIMALE
Anassagora riflette anche sulla differenza tra uomo e animale. Pur sostenendo che entrambi siano ontologicamente simili, individua una distinzione fondamentale: l’uomo possiede le mani, che gli conferiscono la capacità di costruire manufatti e trasformare il mondo intorno a sé. Questa capacità rappresenta un’estensione della mente razionale e segna il progresso della civiltà umana rispetto agli altri esseri viventi.In conclusione, Anassagora è un pensatore che anticipa molte riflessioni filosofiche e scientifiche successive. La sua teoria dei semi e del Nous introduce una visione razionale e organizzata dell’universo, mentre la sua critica alle credenze popolari rappresenta un inno alla libertà di pensiero. Il suo contributo alla filosofia pluralista e alla cultura ateniese del V secolo a.C. è un esempio di come il pensiero razionale possa sfidare e superare le barriere imposte dalla tradizione.