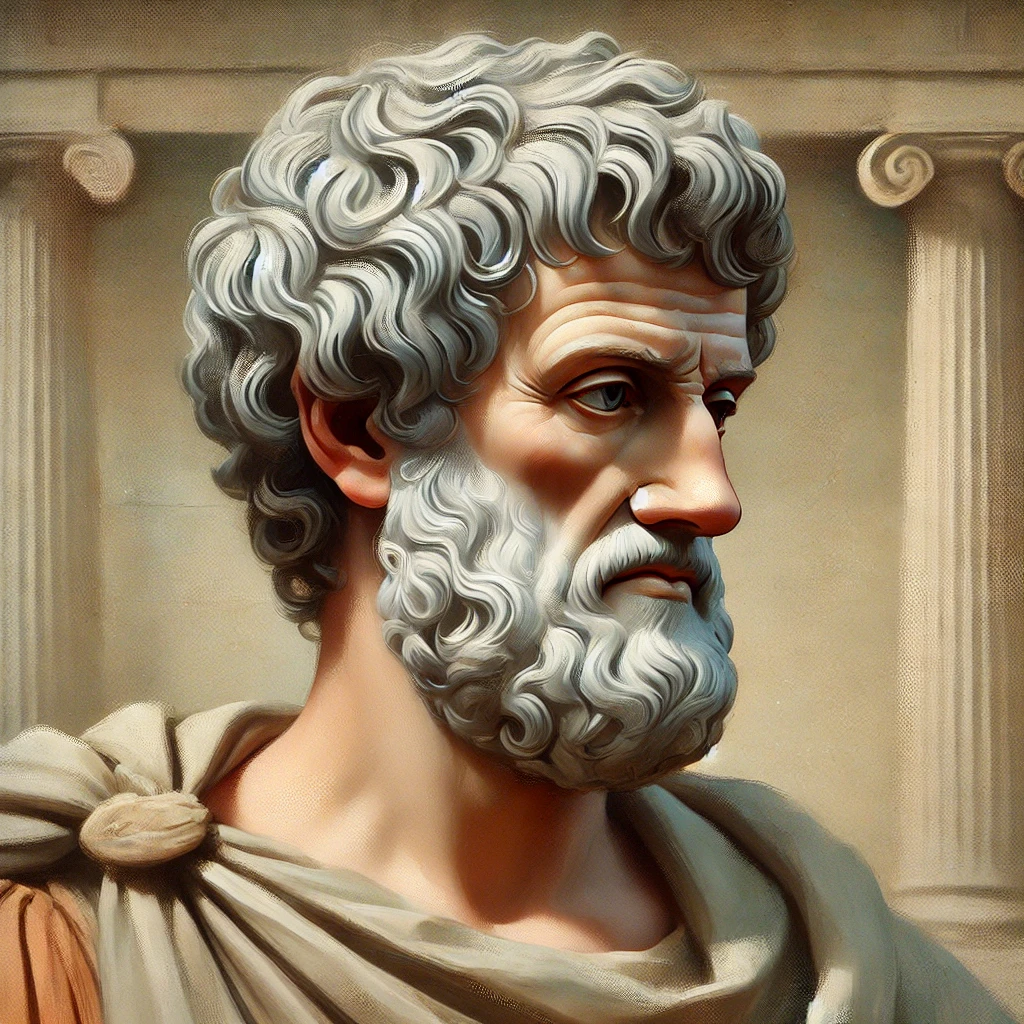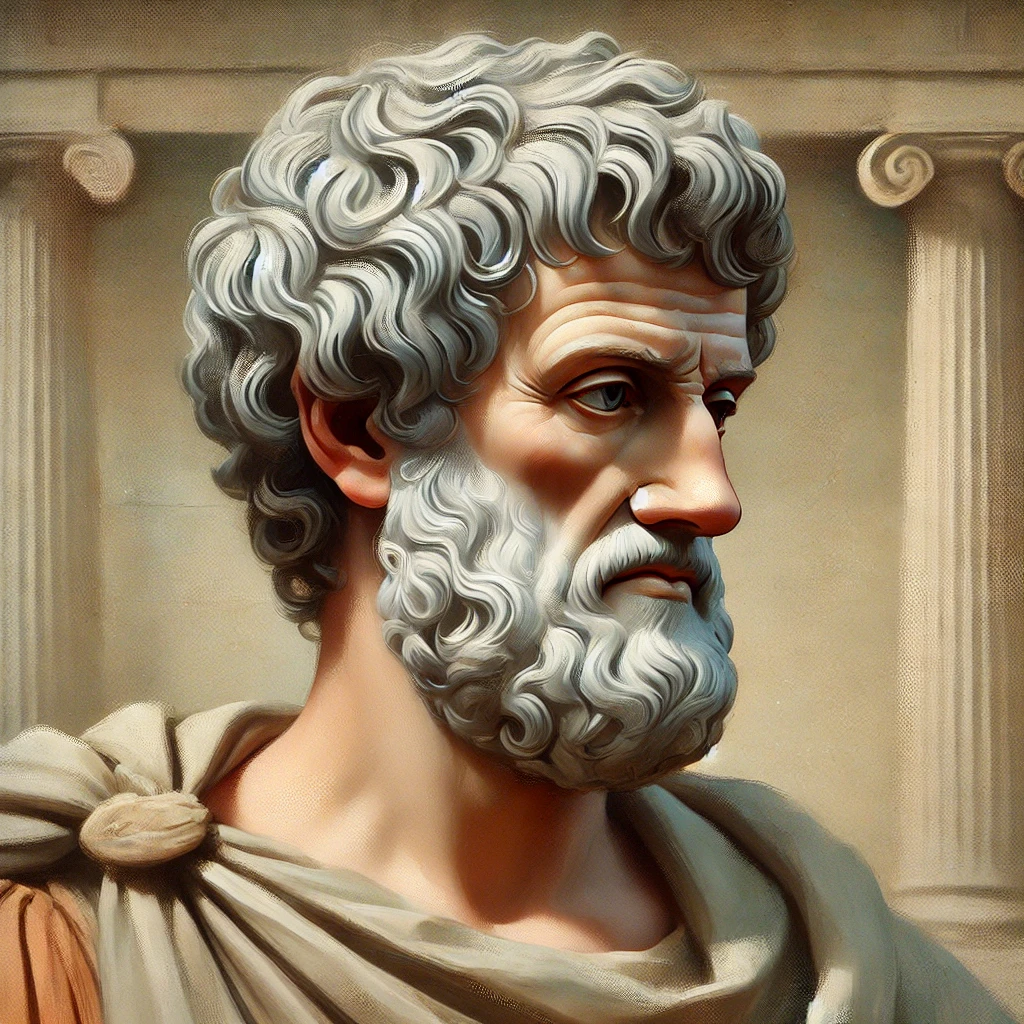
Aristotele è una delle figure più influenti della filosofia antica. Tuttavia, non tutti i suoi scritti sono giunti
fino a noi. Egli distingueva tra scritti essoterici, destinati al pubblico, e scritti esoterici
, riservati a un uso privato e accademico.
La vita di Aristotele fu segnata da tre eventi fondamentali:
- L’incontro con Platone: Aristotele fu allievo dell’Accademia e studiò sotto la guida di Platone, assimilando e successivamente sviluppando le sue teorie.
- Il ruolo di precettore di Alessandro Magno: Aristotele educò il futuro conquistatore, trasmettendogli una formazione etica e filosofica.
- La fondazione del Liceo: Dopo la morte di Platone, Aristotele fondò la sua scuola ad Atene, dove elaborò e insegnò il suo pensiero.
LA CONCEZIONE ARISTOTELICA DEL SAPERE
Aristotele sosteneva la paideia (παιδεία), ovvero l'educazione e la formazione dell’individuo attraverso il sapere. Egli considerava la conoscenza essenziale, ma rifiutava una gerarchia assoluta tra le diverse discipline: ogni sapere ha valore all'interno del proprio ambito. Alcuni saperi hanno una funzione universale, altri una funzione particolare, ma tutti sono privi di giudizi di valore (avalutativi).Aristotele fu il primo a strutturare una vera e propria enciclopedia delle scienze. Il termine "enciclopedia" deriva dall'espressione greca ἐν κύκλῳ παιδεία (en kyklō paideia), che significa "sapere messo in circolo", con la funzione storica di trasmettere e formare attraverso la conoscenza.
Le scienze, secondo Aristotele, si dividono in tre grandi categorie. La prima è quella delle scienze teoretiche , che si occupano della conoscenza pura, ovvero di ciò che è necessario e immutabile ma che risulta astratto e speculativo:
- Metafisica, che Aristotele definisce "filosofia prima".
- Matematica, disciplina che si occupa di quantità e relazioni astratte.
- Fisica, lo studio della natura e delle sue leggi.
- Etica, lo studio della condotta e della virtù.
- Politica, l’analisi delle forme di governo e dell’organizzazione sociale.
- Arte, l'abilità di creare opere.
- Retorica, l'arte del discorso persuasivo.
- Letteratura, la produzione poetica e narrativa.
Nel definire l'enciclopedia delle scienze, Aristotele distingue tra prassi e poiesis: agire, infatti, significa compiere scelte etiche e politiche che influenzano la vita sociale e individuale. Al contrario, fare (poiesis) riguarda la produzione di manufatti o opere artistiche. Da questa distinzione emerge che l’essere umano è capace di pensare, agire e fare. Tuttavia, questi ambiti non sono sovrapponibili: chi si occupa di etica e prassi non può, contemporaneamente, essere metafisico.
LA LOGICA
Aristotele è considerato il padre della logica, la disciplina che studia il ragionamento e il pensiero. Egli concepisce la logica come un organon, ovvero uno strumento essenziale per il pensiero filosofico. A differenza delle altre discipline, la logica non rientra nell'enciclopedia delle scienze, poiché non è un sapere autonomo, ma un mezzo indispensabile per tutte le scienze. La sua funzione principale è spiegare come procede il ragionamento e giustificare la validità delle affermazioni.La logica si manifesta nel linguaggio quando le riflessioni vengono elaborate in modo coerente e rigoroso. Tuttavia, il rapporto tra logica e linguaggio non è unidirezionale: se da un lato il linguaggio esprime il pensiero, dall’altro può influenzarlo, modellando la struttura del ragionamento. Per questo motivo, il filosofo ha il compito di stabilire le regole che permettono di parlare e argomentare in modo giustificato e sensato.
Le riflessioni di Aristotele sulla logica sono state tramandate attraverso diversi testi, che solo successivamente sono stati riuniti sotto il titolo di Organon. Questo perchè, ai tempi di Aristotele non esisteva ancora il termine "logica" come disciplina autonoma. Fu solo con gli stoici che si iniziò a usare questa denominazione per indicare lo studio sistematico delle regole del ragionamento.
LE TRE PARTI DELLA LOGICA
Secondo Aristotele, la logica si suddivide in tre ambiti fondamentali:- Logica del concetto, che riguarda la definizione e la classificazione dei termini.
- Logica della proposizione, che studia le affermazioni e il loro significato.
- Logica del ragionamento, che si occupa della concatenazione delle proposizioni in modo coerente.
La Logica del Concetto
All’interno della sua riflessione logica, Aristotele non utilizza mai il termine concetto, ma impiega il termine "universale", con il quale si riferisce alle categorie generali che organizzano la conoscenza.Ogni concetto possiede due caratteristiche fondamentali, in rapporto inversamente proporzionale:
- L’estensione: indica l’ampiezza del concetto e corrisponde al genere. Più un concetto è esteso, minore è la sua specificità.
- La comprensione: rappresenta il numero di caratteristiche che un concetto possiede e corrisponde alla specie. Maggiore è la comprensione, minore è l’estensione.
La specificità di un concetto varia, dunque, in relazione alla struttura logico-semantica in cui è inserito. Le specie permettono di approfondire un concetto, riducendone l’estensione ma aumentandone la determinazione.
Aristotele individua però due limiti fondamentali nella gerarchia concettuale:
- L’estensione massima: essa corrisponde alla sostanza universale, ovvero il sostrato ontologico, la realtà ultima e incondizionata su cui si fondano tutte le predicazioni. Il termine sostrato deriva dal latino substantia, che significa “ciò che sta sotto” ed è il principio fondamentale dell’essere.
- La comprensione ultima: essa è definita come Tóde ti (τόδε τί), ovvero “questo qui”. Si tratta della specie ultima, che funge esclusivamente da soggetto e non può mai essere predicata. Infatti, tutto ciò che possiede un’estensione può essere predicato, mentre la sostanza ultima è il fondamento di ogni predicazione.
La logica della Proposizione
Aristotele definisce ogni giudizio come una proposizione, ovvero un’affermazione che esprime una relazione tra due concetti. Le proposizioni si distinguono in base a tre caratteristiche fondamentali: la qualità (secondo cui una proposizione può essere positiva o negativa), la quantità (secondo cui una proposizione può essere universale o particolare). Sulla base di ciò, Aristotele introduce e costruisce quello che verrà definito a posteriori come il quadrato logico, uno schema per classificare i giudizi proposizionali secondo le due caratteristiche fondamentali.Tali caratteristiche danno origine a quattro tipi di proposizioni, che vengono identificate con le vocali A, E, I, O:
- A (universale affermativa): "Tutti gli uomini sono mortali."
- E (universale negativa): "Nessun uomo è immortale."
- I (particolare affermativa): "Alcuni uomini sono saggi."
- O (particolare negativa): "Alcuni uomini non sono saggi."
- Contrarietà (A-E): le due proposizioni sono entrambe universali ma di qualità opposta. Non possono essere entrambe vere, ma possono essere entrambe false (Esempio: "Tutti gli uomini sono onesti" (A) e "Nessun uomo è onesto" (E) possono essere entrambe false, perché può esistere un caso intermedio).
- Contraddizione (A-O, E-I): le proposizioni si escludono completamente a vicenda. Se una è vera, l’altra è falsa e viceversa (Esempio: "Tutti i gatti sono neri" (A) e "Alcuni gatti non sono neri" (O) sono contraddittorie, poichè se la prima è falsa, la seconda deve essere vera).
- Subcontrarietà (I-O): le due proposizioni sono entrambe particolari e di qualità opposta. Possono essere entrambe vere, ma non entrambe false (Esempio: "Alcuni cani sono aggressivi" (I) e "Alcuni cani non sono aggressivi" (O) possono essere entrambe vere, perché esistono cani aggressivi e non).
- Sottomissione (A-I, E-O): la verità dell’universale implica la verità della particolare corrispondente, ma non viceversa (Esempio: "Tutti i fiori sono colorati" (A) e "Alcuni fiori sono colorati" (I), in cui se A è vera, anche I è vera. Ma se I è vera, non significa necessariamente che A sia vera).
- Possibilità: qualcosa può accadere, ma non è detto che accada ("Domani potrebbe piovere").
- Impossibilità: qualcosa non può accadere ("Domani non può nevicare a Roma").
- Contingenza: qualcosa può sia accadere che non accadere ("Potrebbe piovere oppure no"). Questa categoria è interessante perché sottostà al principio di non contraddizione: nel momento in cui si realizza una delle due possibilità, l’altra viene esclusa. Tuttavia, se spostiamo questa condizione nel futuro, la contraddizione resta aperta fino al momento della realizzazione.
- Necessità: qualcosa deve accadere e non può non accadere ("Il Sole sorgerà domani").
La Logica del Ragionamento
La logica del ragionamento in Aristotele si concentra sull'uso del sillogismo, che è una forma di argomentazione composta da tre proposizioni: due premesse e una conclusione. Aristotele distingue tra sillogismi deduttivi e sillogismi induttivi, che hanno caratteristiche e scopi diversi.Il sillogismo deduttivo è una forma di ragionamento che parte da premesse generali per arrivare a una conclusione specifica. Questo tipo di sillogismo è valido e vero se le premesse sono vere, e la conclusione segue logicamente da esse. È tipico delle scienze, dove la verità di un'affermazione è misurata dalla sua corrispondenza con la realtà. Il sillogismo deduttivo ha un significato universale, cioè la conclusione vale sempre, indipendentemente dal caso specifico. Un esempio di sillogismo deduttivo è il seguente:
- Premessa maggiore: Tutti gli uomini sono mortali.
- Premessa minore: Socrate è un uomo.
- Conclusione: Socrate è mortale.
Il sillogismo deduttivo può essere affermativo (come nell'esempio) o negativo, ma la sua caratteristica principale è che la conclusione risulta necessariamente vera se le premesse lo sono.
Il sillogismo induttivo, al contrario, non parte da premesse universali, ma da osservazioni particolari o probabili, che portano a una conclusione che probabilmente è vera. È un tipo di ragionamento più dialettico, che cerca di stabilire legami tra le esperienze particolari per arrivare a una verità generale, ma senza la certezza assoluta del sillogismo deduttivo. Le premesse in un sillogismo induttivo sono basate su probabilità e non su verità assolute. Un esempio potrebbe essere:
- Premessa maggiore: La maggior parte degli uomini che conosco è mortale.
- Premessa minore: Socrate è un uomo che conosco.
- Conclusione: Socrate è probabilmente mortale.
Esiste però un altro tipo di sillogismo, quello sofistico, che si distingue da quello induttivo in quanto è caratterizzato da un ragionamento fallace e manipolativo, piuttosto che basato su una valutazione seria delle probabilità. Il sillogismo sofistico non è interessato alla verità o alla probabilità, ma piuttosto a convincere emotivamente l'interlocutore. Non si preoccupa della validità logica o delle prove, ma mira a persuadere, spesso utilizzando argomenti ingannevoli.
In un sillogismo sofistico, la validità logica potrebbe non essere rispettata, e la conclusione potrebbe essere ottenuta usando premesse che sono per lo più opinioni o pregiudizi (definiti da Aristotele endoxa), piuttosto che fatti o verità verificabili. Questo tipo di ragionamento è spesso usato nei dibattiti pubblici o nei discorsi persuasivi.
METAFISICA
La filosofia prima, o metafisica, è la scienza che Aristotele considera la più fondamentale, poiché si occupa dell'essere in quanto essere, cioè della realtà in generale, senza riferimento a un particolare dominio o fenomeno. Secondo Aristotele, la metafisica è essenziale per ogni altra forma di conoscenza, poiché, prima di poter fare astrazioni o indagini più specifiche, è necessario comprendere le nozioni di base dell'essere e della realtà.La metafisica non indaga fenomeni particolari, come fa la scienza fisica, che si occupa di oggetti concreti, ma si concentra sull'essere come tale, cioè su ciò che è comune a tutti gli oggetti e che rende possibile la loro esistenza. L'essere è, quindi, una nozione che abbraccia ogni cosa, e Aristotele lo definisce come sostanza e essenza.
- Sostanza: La sostanza è la condizione stessa dell'esistenza. Aristotele distingue tra ciò che esiste in sé (la sostanza) e ciò che esiste in altro (gli attributi). La sostanza è la base che consente a un oggetto di esistere come ciò che è.
- Essenza: L'essenza è la specificità di ciò che è. Ad esempio, l'essenza dell'uomo è quella che lo rende uomo, distinta dalla specificità di altre entità come l'animale o la pianta. L'essenza definisce l'individuo in quanto tale.
Autosufficienza e Individui
Secondo Aristotele, solo gli individui sono autosufficienti, cioè esistono in sé stessi e non dipendono da nulla d'altro per la loro esistenza. Gli attributi, invece, non sono autosufficienti, ma dipendono dalla sostanza di cui sono attributi.Per esempio, un albero esiste come individuo, ma le sue caratteristiche come "verde" o "alto" non possono esistere indipendentemente dall'albero stesso. Questi attributi sono dipendenti dalla sostanza che li possiede, e quindi non possono essere considerati autosufficienti.
Distinzione da Platone
Un punto fondamentale in cui Aristotele si distacca dalla visione di Platone è il rifiuto dell'idea platonica. Platone sosteneva che esistono Idee o Forme perfette e immutabili, come l'Idea del Bello, che esistono indipendentemente dal mondo sensibile. Aristotele, invece, sostiene che le idee universali non esistono separatamente dalla realtà sensibile. Per Aristotele, la bellezza o qualsiasi altra qualità non ha realtà propria se non è legata a un fenomeno concreto. Non si può parlare di "bello" o "giusto" senza fare riferimento a qualcosa di concreto a cui queste qualità si applicano.Aristotele, quindi, rifiuta il dualismo platonico tra il mondo delle Idee e il mondo sensibile. Per lui, l'essere non è separato in due mondi distinti, ma è unico e indivisibile, e tutte le qualità e forme sono intrinseche agli oggetti del mondo sensibile.
L'empirismo di Aristotele: il Sinolo
Aristotele introduce il concetto di sinolo (dal greco syn = "con" e holon = "tutto"), che indica un composto unitario di materia e forma. In questo modo, ogni essere è una combinazione di materia (la sostanza fisica, che dà "spazio" all'esistenza) e forma (la specificità che determina ciò che un oggetto è, la sua essenza). Per Aristotele, né la materia né la forma esistono separatamente: entrambe sono necessarie per la definizione e l'esistenza di un oggetto.Ad esempio, una statua di marmo è composta da materia (il marmo stesso) e da una forma (la figura scolpita). La statua esiste grazie alla combinazione di questi due aspetti, e senza uno dei due, la statua non esisterebbe.
Sebbene Aristotele sia considerato un empirista perché pone grande enfasi sull'osservazione e l'esperienza sensoriale, non è un relativista gnoseologico. Il relativismo gnoseologico implica che la conoscenza sia relativa alla percezione individuale e che non esista una verità universale. Al contrario, Aristotele sostiene che la conoscenza si fonda su principi universali e che esiste una realtà oggettiva e accessibile tramite l'osservazione scientifica e la razionalità. La sua epistemologia, quindi, è una sintesi tra empirismo e razionalismo, in quanto la percezione sensoriale è il punto di partenza per l'indagine filosofica, ma l'intelletto è quello che permette di cogliere la verità universale.
Potenza e Atto
Aristotele sviluppa il concetto di potenza e atto per spiegare il cambiamento e il divenire nel mondo naturale. La potenza rappresenta la possibilità o il potenziale di essere qualcosa, mentre atto è la realizzazione effettiva di quel potenziale. Questi due concetti sono strettamente legati nel processo di divenire, che Aristotele descrive come il passaggio da una possibilità a una realtà concreta.Un esempio classico di potenza e atto è dato dal seme e dalla pianta. Il seme è in potenza rispetto alla pianta, cioè contiene la possibilità di diventare una pianta, ma non è ancora una pianta. Quando il seme cresce e si sviluppa, si realizza come atto, cioè come pianta effettiva. La pianta, a sua volta, è in potenza rispetto ai suoi frutti futuri, che rappresentano una nuova possibilità.
In questo senso, potenza e atto sono sovrapponibili e interconnessi: il seme è sia potenza che atto della pianta. Aristotele applica questo concetto a tutti gli individui e i fenomeni naturali, considerando il processo di divenire come una continua realizzazione del potenziale presente in ogni cosa.
I Limiti del Divenire: L'Atto Puro e la Materia Inerte
Aristotele stabilisce due limiti che definiscono il concetto di divenire. Da un lato, c'è l'atto puro, che rappresenta la realizzazione completa e assoluta del potenziale. Questo atto puro, secondo Aristotele, è identificato con Dio o con il motore immobile (un concetto che Aristotele sviluppa nella sua metafisica). Dio è pensiero di pensiero, ovvero il pensiero che pensa sé stesso, senza necessità di sviluppo o cambiamento. Questo tipo di atto è perfetto e immutabile: non c'è altro al di fuori di sé. In questo contesto, l'atto puro rappresenta una condizione senza mancanza (steresi), ed è l'assenza di potenza, in quanto non c'è nulla da realizzare, nessuna possibilità da sviluppare.Dall'altro lato, Aristotele descrive anche il limite opposto: la materia inerte, che è potenza assoluta. La materia inerte non ha alcuna forma, quindi è pura potenza, senza alcuna attualizzazione. È la possibilità senza alcuna realizzazione. La materia, in questo stato, è priva di forma e struttura, ed è la base dalla quale prende avvio ogni processo di sviluppo.
Le Quattro Cause: La Giustificazione della Visione Aristotelica
Aristotele giustifica la sua visione del mondo attraverso la dottrina delle quattro cause. Secondo Aristotele, ogni fenomeno o cambiamento nel mondo naturale può essere spiegato tramite quattro tipi di cause che ne determinano l'esistenza e il divenire:- Causa materiale: materia di cui esiste qualcosa. Ad esempio, la causa materiale di una statua è il blocco di marmo.
- Causa formale: forma o essenza di un oggetto. Per la statua, la causa formale è la forma scolpita che l'artista dà al marmo.
- Causa efficiente: forza o principio che produce il cambiamento o l'esistenza di una cosa. Nel caso della statua, la causa efficiente è l'artista che la scolpisce.
- Causa finale: fine o scopo per cui qualcosa esiste o cambia. Nel caso della statua, la causa finale è l'intento artistico dell'artista, che vuole creare una rappresentazione.
Aristotele e il Fissismo Biologico
Aristotele è considerato il fondatore di un pensiero fissista in ambito biologico. In contrasto con la teoria dell'evoluzione, che suggerisce un cambiamento progressivo delle specie nel tempo, Aristotele sostiene che le specie viventi sono fisse e immutabili. Non esiste un'evoluzione tra le specie, ma piuttosto un sviluppo all'interno di ogni specie. Ogni organismo ha una propria natura e una propria potenzialità di sviluppo, che si realizza in modo continuo e senza il passaggio da una specie all'altra.Secondo Aristotele, le specie sono fisse nel loro essere: ogni organismo si sviluppa dalla materia prima secondo un determinato programma interno che porta alla sua completa realizzazione. In altre parole, le forme di vita si sviluppano secondo una direzione interna e finale che non è soggetta a mutamenti evolutivi in senso darwiniano, ma a una continua realizzazione del proprio potenziale.
FISICA
Aristotele, nella sua dottrina fisica, concepisce l’universo come diviso in due sfere principali: il mondo celeste e il mondo terrestre. Questa distinzione è fondamentale per comprendere la sua visione della realtà naturale e del movimento.Il mondo celeste
Il mondo celeste, detto anche sovralunare, è costituito da una sostanza speciale e diversa dai quattro elementi terrestri: l’Etere. Questo elemento, di cui parla anche Platone nel Timeo, è la quinta essenza, la più nobile e perfetta. Aristotele lo descrive come eterno, perché non nasce e non muore; incorruttibile, perché non si deteriora né cambia nel tempo; immutabile, perché non subisce trasformazioni come avviene nel mondo terrestre. Essendo la sostanza più pura, è anche la più vicina a Dio.L’intero cosmo aristotelico si basa su una visione geocentrica, ripresa poi da Tolomeo, in cui la Terra occupa il centro dell’universo. Attorno a essa ruotano sfere concentriche che contengono i vari corpi celesti, tra cui Sole, Luna e pianeti. Secondo Aristotele, il moto di queste sfere è circolare, perché il cerchio è la figura perfetta per eccellenza. La sfera più esterna è quella delle stelle fisse, che segna il confine dell’universo e il punto più vicino a Dio. L’intera struttura è chiusa e gerarchica: più un corpo celeste è lontano dalla Terra, più si avvicina alla perfezione.
Il mondo terrestre
Al di sotto della Luna si trova invece il mondo terrestre, detto anche sublunare, che si distingue dal mondo celeste per la sua imperfezione e la sua corruttibilità. Tutto ciò che appartiene a questa sfera nasce, cambia e muore, seguendo il ciclo naturale delle cose. Il mondo terrestre è costituito dai quattro elementi fondamentali – terra, acqua, aria e fuoco – che, in varie combinazioni, danno origine a tutti i fenomeni naturali. Ogni elemento possiede due delle quattro qualità fondamentali:| Elemento | Qualità |
|---|---|
| Terra | Freddo e secco |
| Acqua | Freddo e umido |
| Aria | Caldo e umido |
| Fuoco | Caldo e secco |
Aristotele distingue anche i diversi tipi di movimento. Nel mondo terrestre prevale il movimento naturale , che segue le inclinazioni proprie degli elementi: la terra e l’acqua tendono a scendere, mentre l’aria e il fuoco tendono a salire. Quando un corpo si muove in modo diverso dalla sua tendenza naturale, si parla di movimento violento, che avviene solo se viene esercitata una forza esterna. Nel mondo celeste, invece, il movimento è perfetto e circolare, poiché i corpi celesti si muovono in maniera eterna e immutabile, senza mai fermarsi.
Questa visione del cosmo, in cui il mondo celeste è caratterizzato dalla perfezione e dalla stabilità mentre il mondo terrestre è soggetto al cambiamento, influenzerà profondamente la scienza e la filosofia per secoli. La distinzione tra i due mondi, fondata sulla natura diversa degli elementi che li compongono e sui diversi tipi di movimento che li caratterizzano, resterà centrale fino alla rivoluzione copernicana, quando il modello geocentrico verrà messo in discussione.
I quattro regni
Aristotele distingue quattro regni naturali, ciascuno caratterizzato da una diversa organizzazione della materia e dalla presenza o meno di un'anima.- Regno inorganico: il primo regno, che comprende i corpi inanimati. Qui la materia è aggregata senza una vera organizzazione, priva di una forma specifica che le dia vita.
- Regno vegetale: il secondo regno, in cui compare l’anima vegetativa, responsabile delle funzioni vitali di base come la crescita, la riproduzione e la respirazione.
- Regno animale: il terzo regno. Oltre alla funzione vegetativa, è presente l’anima sensitiva, che consente agli esseri viventi di percepire il mondo attraverso i sensi e di muoversi in risposta agli stimoli.
- Regno umano: esso si distingue dagli altri perché la sua anima non è solo vegetativa e sensitiva, ma anche intellettiva, permettendo all’uomo di ragionare, comprendere e riflettere.
Dottrina gnoseologica
Nel suo approccio alla conoscenza, Aristotele adotta una prospettiva empirista, ritenendo che il sapere derivi dall’esperienza sensibile e non da idee innate. Il processo di conoscenza avviene attraverso un metodo induttivo, che parte dall’osservazione dei fenomeni per giungere a principi generali. Per spiegare come si sviluppa la conoscenza, Aristotele distingue quattro livelli:- Il primo livello è la sensazione, ovvero la capacità di cogliere le qualità degli oggetti attraverso i cinque sensi. Vista, udito, tatto, gusto e olfatto ci permettono di entrare in contatto con la realtà e raccogliere informazioni sugli oggetti che ci circondano.
- Il secondo livello è il senso comune, che non deve essere confuso con l’idea moderna di opinione condivisa. Per Aristotele, il senso comune è la facoltà che unifica le informazioni provenienti dai sensi, permettendoci di percepire un oggetto nella sua totalità.
- Il terzo livello è l’immaginazione, che non si limita a riprodurre le percezioni sensibili, ma le rielabora, formando immagini generali che trascendono i singoli dati sensoriali. Ad esempio, mentre la sensazione ci permette di percepire un’arancia specifica, l’immaginazione ci consente di formare un concetto più generale di “arancia” come frutto.
- il quarto livellola memoria, che conserva nel tempo le immagini create dall’immaginazione, permettendo all’individuo di riconoscere e richiamare alla mente esperienze passate.
SCIENZE PRATICHE
Aristotele considera l’etica e la politica come le due principali scienze pratiche, distinguendole dalle scienze teoretiche e poietiche. L’etica è strettamente connessa alla politica, tanto che Aristotele la considera una sua introduzione: non si può pensare a un individuo virtuoso senza una comunità ben organizzata. La politica, infatti, è il contesto in cui le virtù morali trovano espressione concreta.L'ETICA
L’etica di Aristotele è razionalista ed eudemonistica. L’eudemonismo (dal greco eudaimonía, "felicità") è la concezione secondo cui il fine ultimo dell’uomo è la felicità. Tuttavia, per Aristotele la felicità non è un piacere passeggero, ma il compimento della propria razionalità. Un uomo sarà felice se esercita la propria ragione e vive in modo equilibrato. Aristotele distingue tra due tipi di virtù:- Virtù etiche, proprie della vita attiva, legate all’interazione con gli altri.
- Virtù dianoetiche, proprie della vita contemplativa, legate alla riflessione e allo studio.
Le Virtù Etiche: Il Giusto Mezzo
Le virtù etiche si apprendono attraverso l’esercizio e l’abitudine (ethos in greco significa proprio "abitudine"). Aristotele sostiene che la virtù è il giusto mezzo tra due estremi opposti, entrambi vizi. Un esempio è dato dal coraggio: esso corrisponde alla virtù che sta tra codardia (difetto) e temerarietà (eccesso). Il comportamento virtuoso è quindi un equilibrio tra due estremi sbagliati.La vita morale si fonda sull’abitudine: più una persona si abitua a comportarsi in modo giusto, più diventerà virtuosa. Per questo, Aristotele sottolinea l’importanza dell’educazione alla virtù, che avviene attraverso l’esempio di modelli virtuosi. In particolare, è fondamentale educare i giovani fin dall’infanzia per abituarli a comportamenti morali corretti.
Le Virtù Dianoetiche: La Vita Contemplativa
Le virtù dianoetiche (dianoia significa "pensiero, riflessione") riguardano l’intelligenza e la conoscenza. Sono tipiche della vita contemplativa, cioè della ricerca intellettuale, e non dipendono dall’interazione sociale. Le principali virtù dianoetiche sono:- Sapienza (sophía): riguarda la filosofia e la ricerca della verità.
- Intelligenza (nous): la capacità di comprendere immediatamente le cose.
- Scienza (epistéme): il sapere dimostrabile e sistematico.
- Prudenza (phronesis): la capacità di giudicare correttamente nella vita quotidiana.
- Arte (téchne): la conoscenza pratica legata alla produzione (artigianato, medicina, ecc.).
LA POLITICA
Aristotele considera la politica la scienza più elevata tra quelle pratiche, perché ha il compito di organizzare la comunità per garantire una vita virtuosa e felice a tutti i cittadini. L’uomo, infatti, è per natura un "animale politico" (zoon politikon), cioè non può vivere bene al di fuori della polis (la città-stato).Le Forme di Governo: Giuste e Corrotte
Aristotele classifica le forme di governo in base a due criteri: chi detiene il potere (uno, pochi, molti) e se il governo persegue il bene comune o l’interesse personale.| Numero di governanti | Governo Giusto (Virtù e Bene Comune) | Governo Corrotto (Forza e Interesse Personale) |
|---|---|---|
| Uno | Pochi | Molti |
| Monarchia | Aristocrazia | Politìa |
| Tirannide | Oligarchia | Demagogia |
- Monarchia → governo di un solo uomo giusto e virtuoso, che guida per il bene di tutti. Se degenera, diventa tirannide, dove il sovrano governa con la forza e per il proprio interesse.
- Aristocrazia → governo dei migliori (aristoi), cioè di pochi individui virtuosi e saggi. Se degenera, diventa oligarchia, in cui pochi governano solo per il proprio vantaggio economico.
- Politìa → è la forma migliore, un governo misto in cui partecipano molti cittadini, soprattutto la classe media. Se degenera, diventa demagogia (una forma corrotta di democrazia), in cui i politici manipolano il popolo per ottenere consenso.
L’Importanza della Classe Media
Aristotele ritiene che la classe media sia la più adatta a governare, perché:- Non è né troppo ricca né troppo povera, quindi è più equilibrata.
- Ha risolto i problemi materiali e può concentrarsi sulla virtù.
- Evita gli eccessi della lotta tra ricchi e poveri.
A differenza di Platone, Aristotele valorizza la famiglia, perché è il primo ambiente in cui si imparano le virtù e si diventa buoni cittadini. Lo Stato deve quindi educare i cittadini alla virtù, garantendo un’educazione morale e politica adeguata.
LE SCIENZE POIETICHE
Aristotele distingue dalle altre le scienze poietiche, che riguardano la produzione e la creazione, come la retorica e l'arte. Secondo Aristotele, gli strumenti di persuasione sono neutri, e il loro valore dipende dall’uso che ne fa chi li adopera. I sofisti, ad esempio, utilizzano la retorica in modo negativo, piegandola a fini manipolativi, mentre essa di per sé è solo un mezzo per persuadere.La Retorica secondo Aristotele
La retorica è l'arte del parlare persuasivo e si rivolge prevalentemente alla parte emotiva delle persone. Si basa sugli entimemi, che sono sillogismi abbreviati, spesso impliciti, utilizzati per convincere l’uditorio. Aristotele classifica i discorsi retorici in tre categorie principali:- Deliberativi – utilizzati nelle assemblee politiche per persuadere o dissuadere un pubblico riguardo a decisioni future.
- Giudiziari – impiegati nei processi per accusare o difendere qualcuno.
- Epidittici – mirano a elogiare o biasimare qualcuno o qualcosa, e sono tipici dei discorsi commemorativi e delle orazioni funebri.
L'Arte e la Mimesi
A differenza di Platone, Aristotele non ha una concezione negativa dell’arte. Secondo lui, essa si basa sulla mimesi, ovvero sull’imitazione della realtà. Tuttavia, questa imitazione non è un mero riflesso passivo della realtà, bensì un mezzo per comprendere meglio il mondo e le emozioni umane.La mimesi è positiva, perché consente di sperimentare situazioni senza esserne direttamente coinvolti, aiutando così la comprensione e l'apprendimento. Un esempio fondamentale è la tragedia classica, che secondo Aristotele ha una funzione catartica.
La Catarsi nella Tragedia
Il concetto di catarsi deriva dal greco katharsis, che significa "purificazione". Nella tragedia, gli spettatori provano emozioni intense come pietà e terrore, che li aiutano a liberarsi dalle proprie passioni eccessive. Questo meccanismo emotivo permette di raggiungere una maggiore consapevolezza di sé e della condizione umana.La tragedia classica riesce a coinvolgere profondamente il pubblico, pur mantenendolo in una posizione indiretta rispetto agli eventi rappresentati. Il pubblico soffre con i personaggi, ma senza essere direttamente toccato dalle loro sventure, il che rende l'esperienza educativa e purificatrice.