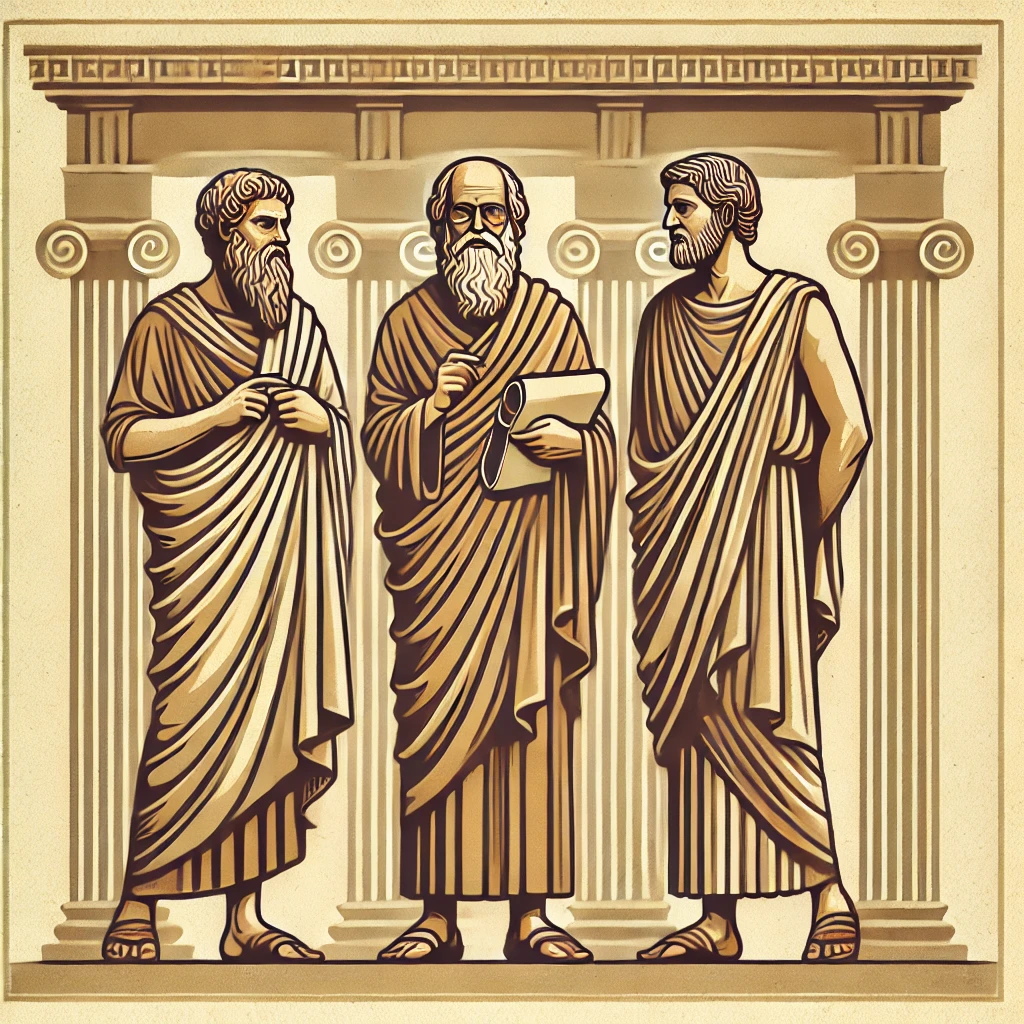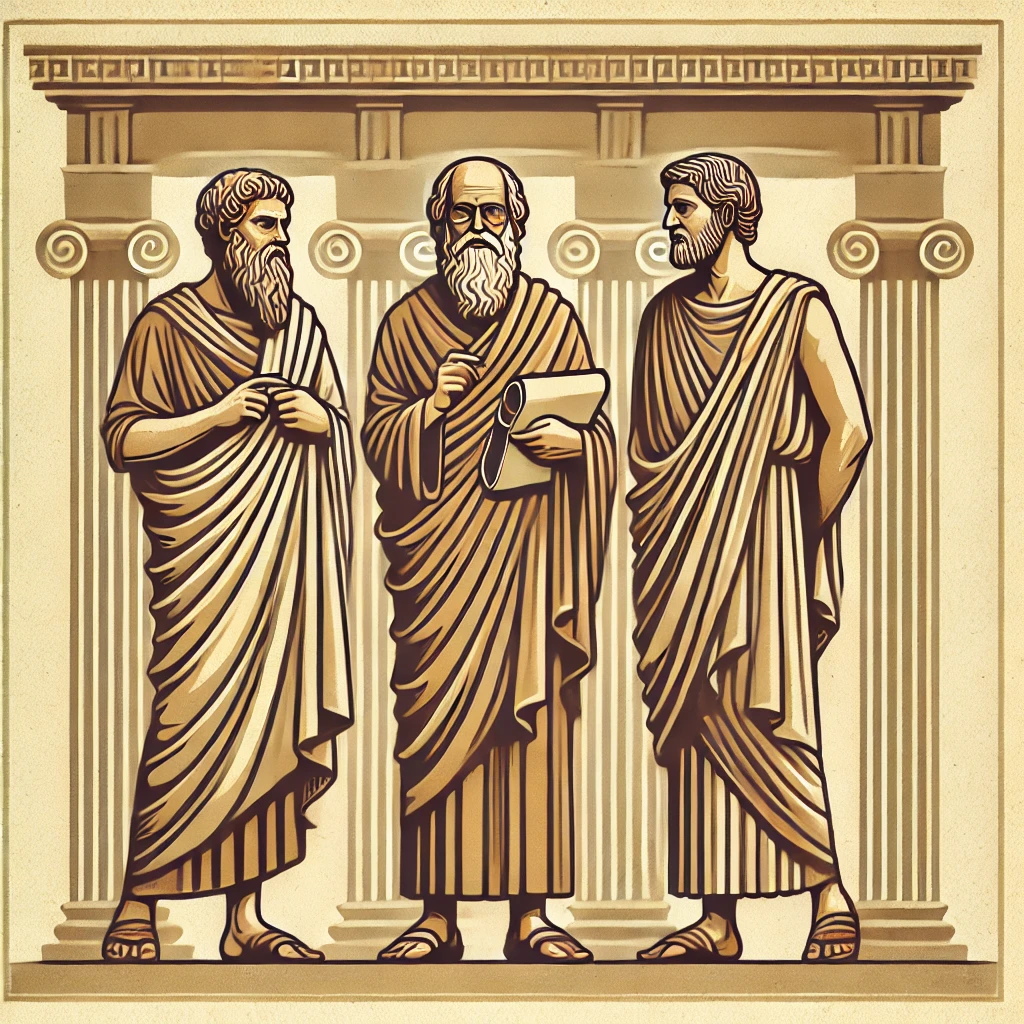
La Scuola Eleatica, a differenza di quella Pitagorica, non si caratterizza come un’organizzazione strutturata con maestri e discepoli formalmente riconosciuti. Deve il suo nome al luogo in cui si sviluppò, la città di Elea (l’odierna Ascea, ovvero Salerno, in Campania). Nonostante non sia chiaro chi ne sia stato il fondatore, si attribuisce la nascita di questa scuola filosofica a due figure centrali: Senofane di Colofone e Parmenide di Elea. Tuttavia, è proprio Parmenide, figura di spicco, che dà il nome alla scuola. Altri filosofi importanti che vi appartengono sono Melisso e Zenone di Elea. La Scuola Eleatica si distingue per la sua riflessione sull’essere, il pensiero ontologico e il rigore logico con cui i suoi rappresentanti affrontarono temi fondamentali della filosofia, come l’unità e l’immutabilità della realtà, in opposizione alle apparenze del molteplice e del mutevole.
SENOFANE DI COLOFONE
Senofane di Colofone è noto per la sua critica all'antropomorfismo religioso, cioè all’attribuzione agli dèi di caratteristiche umane. Egli riteneva che tale visione fosse una proiezione delle limitazioni umane, incapaci di concepire una divinità al di fuori della propria esperienza sensibile. In filosofia, il termine "Dio" viene associato all'universale, ovvero alla dimensione più astratta e razionale del pensiero. L'universale, secondo Senofane, può essere suddiviso in due aspetti principali:- Universale razionale, che deriva dall'elaborazione logica.
- Universale concettuale, che nasce dall’intelletto e dalla capacità di ordinare i dati provenienti dall’esperienza.
- I sensi: essi forniscono informazioni immediate sul mondo esterno attraverso l’esperienza diretta.
- L’intelletto: Questa facoltà rielabora i dati sensoriali, creando concetti. I concetti sono il risultato dell’ordine che la mente impone sulle esperienze sensoriali di oggetti simili. Ad esempio, la parola "albero" rappresenta un concetto che riassume e organizza l’esperienza di molti alberi concreti.
- La ragione: È la facoltà più astratta, che organizza i concetti in idee. Le idee, come quella di "mondo", non derivano dall’esperienza diretta ma da un’elaborazione puramente razionale.
Senofane fa poi una distinzione tra dimostrazione e conoscenza: la dimostrazione è un ragionamento logico e ordinato, che può dimostrare razionalmente l’esistenza di un’entità come Dio (universale massimo). La conoscenza, invece, richiede la coincidenza tra pensiero e realtà, cioè tra ciò che pensiamo e ciò che possiamo verificare con l’esperienza sensibile.
Questa distinzione solleva una questione cruciale: tutto ciò che l’essere umano pensa è reale?
Senofane anticipa un dibattito che sarà centrale nella Scuola Eleatica: il rapporto tra pensiero e realtà.
Zenone di Elea distingue tra realtà fattuale (ciò che esiste nella realtà concreta) e realtà intellettuale (ciò che esiste solo nella mente, come un pensiero o un’idea). Parmenide, al contrario, sostiene che realtà fattuale e realtà intellettuale coincidano, ritenendo che l’essere pensato e l’essere reale siano la stessa cosa. Con questa riflessione, Senofane pone le basi per una discussione sull’ontologia e sul rapporto tra l’intelletto umano e l’essere.
PARMENIDE DI ELEA
Parmenide di Elea è noto non solo come filosofo, ma anche come poeta, poiché esprimeva le sue idee in versi. In epoca antica, i poeti erano considerati intermediari tra l’umano e il divino, privilegiati dalle Muse e dagli dèi per la loro capacità di comunicare verità universali. Questa caratteristica emerge nella sua opera, tradizionalmente intitolata Sulla Natura (Περὶ φύσεως), un poema che combina filosofia e mitologia per trasmettere il suo pensiero.Nel poema, Parmenide narra un viaggio allegorico, che inizia di notte e si conclude di giorno: guidato dalle figlie del Sole, giunge al cospetto di Dike (Δίκη), la Giustizia, che stabilisce le parti, la misura che ciascuno deve tenere. Durante questo incontro, Dike gli rivela due vie (Odos, da cui Meta Odos, ovvero il metodo con cui si raggiunge la conoscenza) fondamentali della conoscenza:
- La via dell’Essere: percorribile, conduce alla verità (Aletheia, ἀλήθεια).
- La via del Non-Essere: non percorribile, perché il non-essere è impensabile e inesprimibile.
In particolare, Parmenide distingue tra due forme di conoscenza: Aletheia e Doxa.
L’aletheia (ἀλήθεια): indica la verità, una conoscenza certa, valida, universale e non nascosta (il termine deriva da alfa privativo e lanthano, "nascondere"). La verità non è accessibile ai sensi, ma solo al Nous (νοῦς), l’intelletto, che consente di cogliere l’essere in quanto tale.
La Doxa (δόξα): rappresenta l’opinione, una conoscenza incerta, parziale e basata sui sensi. La doxa è ciò che si manifesta (da doceo, "mostrare"), ma non corrisponde alla realtà dell’essere, bensì a un’apparenza illusoria, una generalizzazione.
Per Parmenide, affidarsi ai sensi porta alla doxa, mentre il Nous consente di raggiungere l’aletheia.
Parmenide definisce quindi l’essere come:
- Conoscibile: l’essere può essere conosciuto attraverso il pensiero (nous).
- Dicibile: il linguaggio può esprimere l’essere, poiché pensiero e linguaggio coincidono con la realtà.
- Unico, eterno e immutabile: l’essere è uno, perché il non-essere è impensabile; è eterno e immutabile, perché il cambiamento implicherebbe un passaggio dal non-essere all’essere, cosa impossibile.
Con la sua distinzione tra aletheia e doxa, Parmenide pone le basi per un approccio rigoroso alla conoscenza e all’ontologia. La sua riflessione influenza profondamente la filosofia successiva, specialmente Platone e Aristotele, che elaboreranno ulteriormente il rapporto tra essere, pensiero e realtà.
ZENONE DI ELEA
Zenone di Elea (V secolo a.C.) è uno dei filosofi più celebri dell'antichità, noto soprattutto per i suoi paradossi, ossia argomentazioni che, pur essendo logicamente coerenti, portano a conclusioni assurde o contrarie all'evidenza sensibile. Il termine "paradosso" deriva dal greco "para-doxa" (παρά-δόξα), che significa "contro l'opinione comune". I paradossi di Zenone mirano a difendere le tesi del suo maestro Parmenide, il quale sosteneva che la realtà è una e immutabile, negando la possibilità del movimento e della molteplicità. Zenone utilizza la dimostrazione per assurdo per mostrare che l'idea di spazio, tempo e movimento porta a contraddizioni.Il paradosso dello stadio
Immaginiamo di dover attraversare uno stadio da un punto A a un punto B. Per arrivare a B, dobbiamo prima percorrere metà della distanza (A → C), poi la metà della metà (C → D), poi ancora metà della metà della metà, e così via all’infinito.- Problema: Dato che il numero di divisioni è infinito, sembrerebbe che il moto non possa mai iniziare, perché ogni movimento presuppone di aver superato infiniti punti precedenti.
- Conclusione: Se per muoverci dobbiamo prima superare un numero infinito di frazioni di spazio, il movimento non può avvenire. Tuttavia, questo contraddice l’esperienza quotidiana, che dimostra il contrario.
Il paradosso di Achille e la tartaruga
Immaginiamo una gara tra Achille, simbolo di velocità, e una tartaruga, simbolo di lentezza. Per rendere la sfida più equa, concediamo alla tartaruga un vantaggio iniziale di 10 metri.- Problema: Quando Achille raggiunge il punto iniziale della tartaruga (10 metri), la tartaruga sarà avanzata un po’ più avanti (es. 1 metro). Quando Achille raggiunge i successivi 11 metri, la tartaruga sarebbe ancora più avanti (es. 1,1 metri). Questo processo continua all’infinito, con Achille che si avvicina sempre di più ma senza raggiungere mai completamente la tartaruga.
- Conclusione: Se ogni volta Achille deve "recuperare" una distanza che si riduce progressivamente, sembrerebbe che non possa mai raggiungere la tartaruga, anche se nella realtà sappiamo che prima o poi la supera.
Il significato dei paradossi
I paradossi di Zenone mettono in crisi l'intuizione comune del movimento e del continuo. Il loro obiettivo non è negare il movimento in senso pratico, ma mostrare che il concetto stesso di spazio e tempo infinito porta a contraddizioni logiche.Le implicazioni filosofiche sono diverse: Zenone dimostra che un ragionamento formalmente corretto può portare a conclusioni assurde. Ciò suggerisce che la realtà intellettuale non sempre corrisponde alla realtà fattuale. Inoltre, Zenone sottolinea l'importanza dell'esperimento: solo attraverso l'osservazione e la verifica empirica possiamo stabilire cosa sia effettivamente possibile nel mondo fisico.
La nascita della dialettica
Oltre ai paradossi, Zenone è ritenuto anche l'inventore della dialettica, un metodo di argomentazione basato sul confutare la tesi dell’avversario mostrando che porta a conseguenze assurde. Nel metodo dialettico, si assume inizialmente per valida la tesi dell'avversario e la si smonta "dall'interno", dimostrando che porta a contraddizioni logiche o assurde. Si conclude quindi che la tesi iniziale è falsa o problematica. Questo metodo sarà poi fondamentale nella filosofia di Socrate, Platone e nella logica aristotelica, ed è ancora oggi alla base del dibattito filosofico e scientifico.