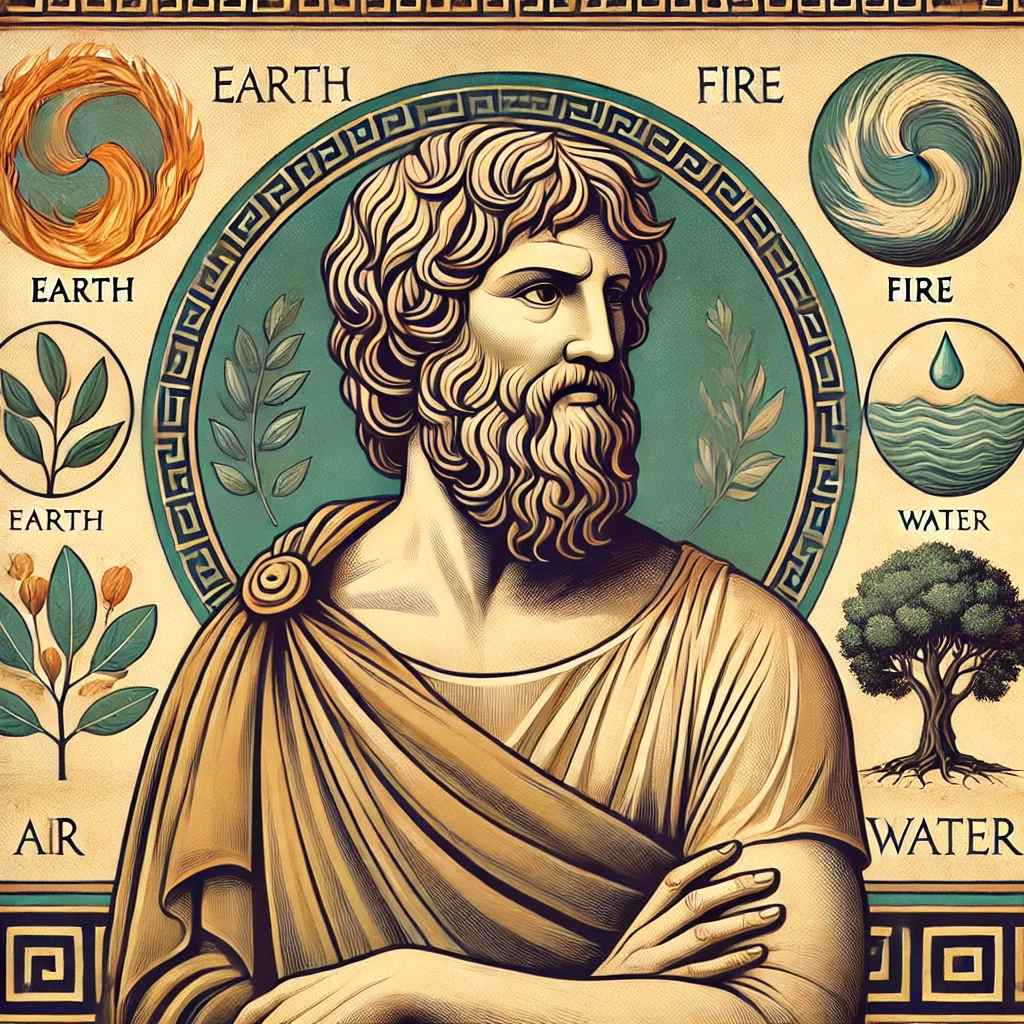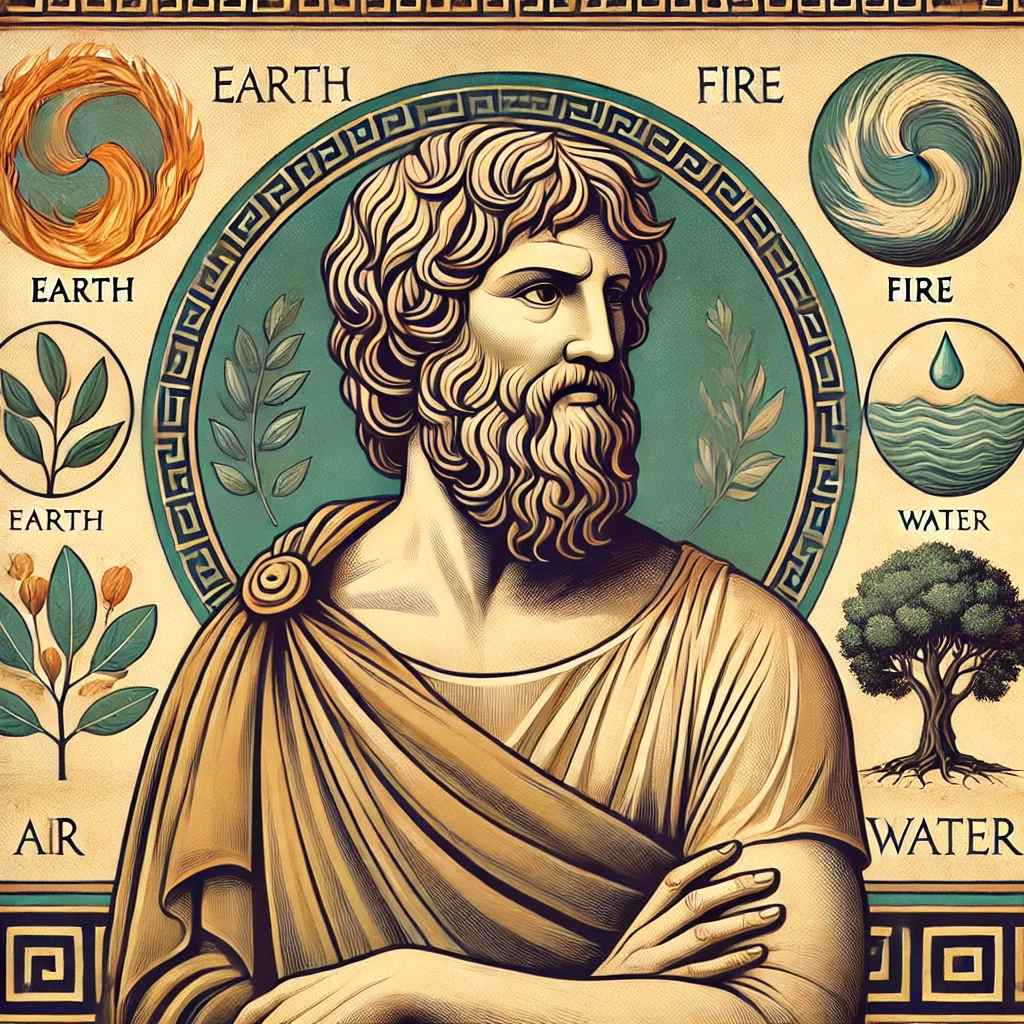
I pluralisti rappresentano una corrente filosofica dell'antica Grecia che, in contrasto con la concezione monistica dei presocratici come Parmenide e Anassimandro, sosteneva la pluralità degli elementi costitutivi della realtà. Tra i principali esponenti di questa scuola spicca Empedocle di Agrigento (V secolo a.C.), un pensatore che coniuga filosofia, scienza e poesia in una visione originale e complessa del cosmo e della vita. Empedocle si distingue per aver proposto una teoria che integra una spiegazione naturalistica con una dimensione etica e spirituale, offrendo una prospettiva unica sulla natura dell’essere e sui meccanismi del cambiamento.
EMPEDOCLE D'AGRIGENTO
Possediamo oltre 100 frammenti attribuiti a Empedocle, una quantità considerevole per un filosofo presocratico. Questi frammenti si suddividono in due opere principali: una con un titolo convenzionale e un'altra intitolata Katharmoi (Purificazione), nome scelto dallo stesso autore. Quest'ultima raccoglie i passi in cui il filosofo tratta temi etici, dimostrando il suo interesse per le questioni morali e spirituali.Empedocle, come Parmenide, unisce filosofia e poesia. In uno dei suoi primi frammenti rende omaggio al maestro eleatico, dichiarando la necessità di invocare la Musa affinché ciò che sta per insegnare al suo discepolo risulti chiaro e comprensibile. Sebbene sia un filosofo, si presenta quindi anche come poeta, utilizzando immagini e caratteri divini per trasmettere il suo pensiero. Questo stile non è solo un espediente letterario, ma riflette una nuova concezione del poeta come figura intermedia tra il divino e il mortale, rendendo il suo messaggio più autorevole e suggestivo.
Empedocle si interroga sull’archè, l’elemento primordiale da cui tutto ha origine, una questione centrale nella filosofia presocratica. Per lui, l’archè non è un principio unico, ma è costituito da quattro radici fondamentali: terra, acqua, aria e fuoco. Questi elementi si combinano e si separano incessantemente sotto l’influenza di due forze opposte e complementari:
- Philia (Amicizia): forza che favorisce l’aggregazione e l’armonia tra le radici.
- Neikos (Contesa): forza che causa la separazione e la disgregazione degli elementi.
L'ESSERE SECONDO EMPEDOCLE
Empedocle, nella sua visione filosofica, descrive l'essere come eterno e caratterizzato da infinite trasformazioni. In uno dei suoi frammenti più celebri scrive:Perché un tempo sono stato fanciullo e fanciulla, e arbusto e uccello e muto pesce che esce dall'acqua.Questo passaggio esprime l'idea che l'esistenza individuale non è univoca, ma ciclica, e che l'essere attraversa continue metamorfosi.
Il pensiero di Empedocle si fonda su una dinamica di aggregazione e disgregazione degli elementi, che sono compresenti e complementari. Ogni volta che un'entità si disgrega, un'altra si aggrega, in un processo eterno e universale. Questa ciclicità cosmica è rappresentata da un ciclo a quattro stadi:
- Massima aggregazione: In questa fase prevale Philia, e le quattro radici – terra, aria, acqua e fuoco – si organizzano in una forma perfetta chiamata Sphairos (dal greco, sfera), simbolo di armonia e completezza. Sebbene la Philia domini, non è mai assoluta, poiché Philia e Neikos sono complementari.
- Vita individuale maggiormente governata da Philia: È un momento di equilibrio tra le forze, in cui le entità individuali possono esistere in relativa armonia. Questa fase corrisponde a una vita più pacifica e stabile, poiché il bilanciamento tra Philia e Neikos consente un’aggregazione sufficiente per la vita individuale.
- Massima disgregazione: In questa fase domina Neikos, e le radici si separano in un vortice caotico. La disgregazione raggiunge il suo apice, dissolvendo le entità in una forma di caos primordiale.
- Vita individuale maggiormente governata da Neikos: È un momento di equilibrio tra le forze, in cui le entità individuali possono esistere in relativa armonia. Questa fase corrisponde a una vita più pacifica e stabile, poiché il bilanciamento tra Philia e Neikos consente un’aggregazione sufficiente per la vita individuale.
METEMSOMATOSI: LA RIGENERAZIONE DEL CORPO
Empedocle adotta una concezione materialista e introduce il concetto di metemsomatosi (dal greco soma, corpo), distinto dalla metempsicosi pitagorica. Mentre i pitagorici parlano della trasmigrazione dell’anima, Empedocle evita di utilizzare il termine "anima" nei suoi scritti, concentrandosi invece sulla rigenerazione corporea. Per lui, il cambiamento non avviene a livello spirituale, ma è un processo puramente fisico e naturale che coinvolge la trasformazione e il rinnovamento della materia.Questa visione riflette il forte legame di Empedocle con il naturalismo, in cui la spiegazione dei fenomeni cosmici e biologici si basa su principi materiali e dinamici, piuttosto che su concetti spirituali o trascendenti.
DOTTRINA GNOSEOLOGICA
Dal punto di vista gnoseologico, Empedocle può essere considerato un empirista. Questo approccio deriva dal termine greco ἐμπειρία (empeiría), che significa "esperienza" o "sensazione". Per Empedocle, la conoscenza ha origine dai sensi: il mondo esterno viene percepito attraverso l’interazione sensoriale, e da questa percezione è possibile estrarre concetti universali di natura concettuale, anziché limitarsi a idee astratte.Secondo Empedocle, la conoscenza si fonda sul principio della similarità: il simile conosce il simile. L’essere umano, come ogni altra entità nell’universo, è costituito dalle quattro radici fondamentali. Poiché tutte le cose condividono queste stesse radici, è possibile conoscerle ontologicamente: ciò che è simile può essere compreso perché fatto della stessa sostanza.
Per accedere a questa conoscenza universale, è essenziale non privilegiare un senso rispetto agli altri. Ogni senso contribuisce in modo parziale alla percezione della realtà, e dare eccessivo credito a uno di essi rischierebbe di fornire una visione incompleta del tutto. Empedocle invita quindi a utilizzare i sensi in modo armonico e integrato, poiché solo dalla combinazione delle percezioni sensoriali si può raggiungere una comprensione completa dell’essere.
KATHARMOI
L’opera Katharmoi (Καθαρμοί, "Purificazioni") di Empedocle è un testo rivolto principalmente agli abitanti di Agrigento e rappresenta un tentativo di educare la comunità su come vivere una vita eticamente e spiritualmente corretta. In questo contesto, Empedocle assume un tono più accessibile rispetto ai frammenti dedicati al suo discepolo, dove si esprime in modo più complesso. Il suo obiettivo nei Katharmoi è guidare un pubblico non intellettuale, spiegando principi fondamentali per migliorare la convivenza e raggiungere un'esistenza armoniosa.Empedocle esorta gli agrigentini a relazionarsi gli uni con gli altri attraverso Philia (Φιλία, amicizia), la forza cosmica che genera armonia e unione. Questo principio non è solo cosmologico, ma anche sociale e politico: vivere secondo Philia significa rispettare il prossimo e collaborare per il bene comune. Questo aspetto etico si riflette anche nella politica, dove Empedocle emerge come uno dei pochi democratici della sua epoca, sostenendo ideali di uguaglianza e giustizia in una società che spesso privilegiava l’aristocrazia.
Nei Katharmoi, Empedocle si presenta con il tono e l’autorità di un medico, professione che praticava con competenza. È attribuita a lui la prima autopsia documentata, e il suo approccio alla medicina si intreccia con la filosofia e l’etica. Tra i precetti che espone, ci sono:
- Non mangiare le fave: Come sostenuto anche da Pitagora, Empedocle consiglia di evitare questo legume, che nel Sud Italia era associato a una malattia, probabilmente il favismo, legato a un deficit genetico (oggi noto come G6PD). Mirko D. Grmek, nella sua opera Storia della malattia all'alba della civiltà occidentale, spiega come questa raccomandazione fosse connessa alla prevenzione dell’anemia mediterranea, una patologia diffusa nella regione.
- Non mangiare carne: Empedocle invita a una dieta vegetariana, ispirata al rispetto per tutte le forme di vita e al concetto di reincarnazione. Per lui, l'uccisione di animali interrompe il ciclo naturale e contraddice il principio di Philia.