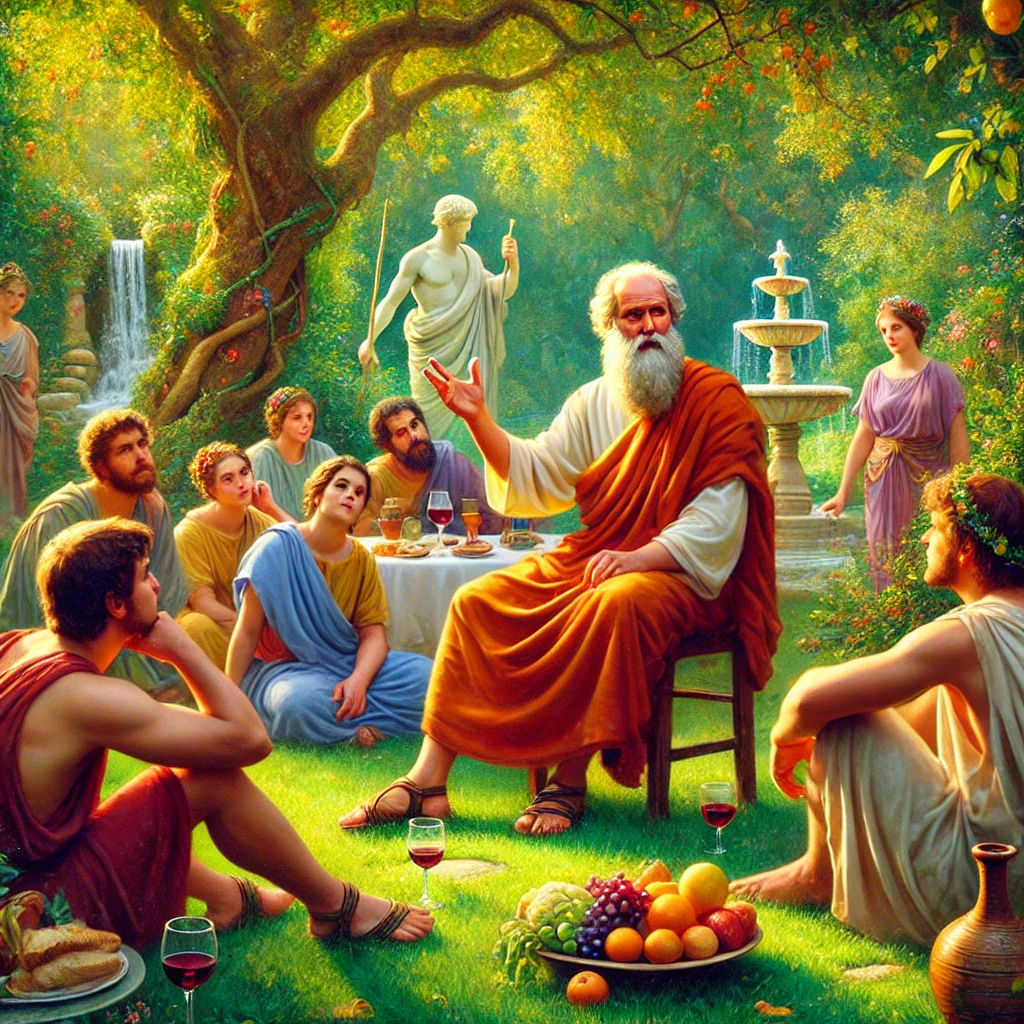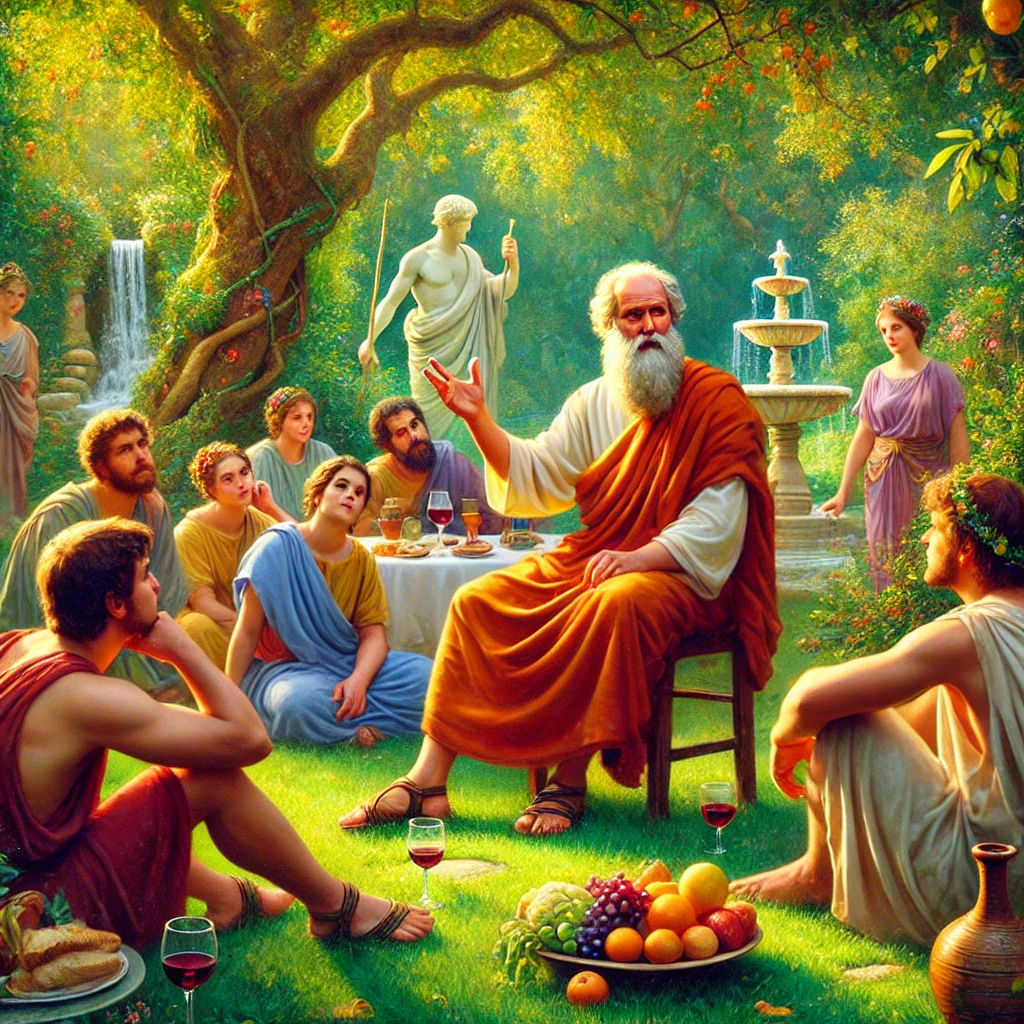
L'epicureismo deve il suo nome al fondatore Epicuro e si propone di individuare le modalità per vivere serenamente, perseguendo così la felicità. Pur avendo un fine etico, l'etica epicurea nasce da un approccio rigoroso alla conoscenza del mondo e non è legata alla politica, rendendo la dottrina fondamentalmente individualista.
LA RIFLESSIONE FISICA E GNOSEOLOGICA
Si possono distinguere due aspetti principali:- Riflessione fisica: Epicuro riprende l'atomismo di Democrito. Secondo questa visione, la natura è costituita da infiniti atomi che, pur essendo in numero illimitato, non seguono un percorso predeterminato, ma si muovono in modo casuale. Tale carattere casuale rende impossibile prevedere con certezza il loro comportamento.
- Dottrina gnoseologica: Gli epicurei si definiscono empiristi e materialisti, ritenendo valida e vera solo la conoscenza sensibile, cioè quella ottenuta attraverso l’esperienza diretta dei sensi. In questo contesto, la mente è in grado di riconoscere e valutare le sensazioni (criterio di verità: accordo o disaccordo del giudizio rispetto alla percezione). Gli epicurei respingono l’idea di una conoscenza universale, privilegiando la comprensione diretta dei concetti rispetto alla mera osservazione dei fenomeni.
LA RICERCA DELLA FELICITÀ
Epicuro propone una filosofia basata sulla ricerca della felicità e della serenità interiore, sintetizzata nella celebre frase "Lathe biosas", cioè "Vivi nascosto". Egli sosteneva il rifiuto della vita pubblica, ciè che l’uomo non deve preoccuparsi della politica e della società, ma dedicarsi alla cura della propria vita interiore e alla ricerca della felicità individuale. inoltre, la felicità viene vista come assenza di turbamenti: la condizione di atarassia (assenza di angoscia) e aponia (assenza di dolore fisico) è il fine ultimo della vita.IL TETRAFARMACO
Epicuro individua quattro paure fondamentali che impediscono di vivere sereni e fornisce una soluzione per ciascuna:- Paura della morte: È irrazionale temerla, perché quando ci siamo noi, la morte non c'è, e quando c’è la morte, noi non ci siamo più. Non possiamo esperire la nostra stessa morte, quindi è un timore privo di senso. (Anche se questa visione è individualista, poiché non tiene conto della paura della morte degli altri).
- Paura del dolore: Se il dolore è troppo forte, conduce rapidamente alla morte. Se invece dura nel tempo, significa che è sopportabile. Quindi il dolore non deve essere fonte di angoscia.
- Paura dell’azione degli dèi: Gli dèi esistono, ma sono esseri perfetti e beati, quindi non si interessano delle vicende umane. Se si occupassero degli uomini, non sarebbero più perfetti, perché si lascerebbero coinvolgere nelle miserie del mondo. Dunque, non dobbiamo temere l’intervento divino.
- Paura di non poter provare piacere (felicità): Il piacere è raggiungibile da tutti, ma bisogna comprendere quali piaceri sono realmente necessari. Qui Epicuro introduce la sua dottrina edonistica.
LA DOTTRINA EDONISTICA
Epicuro distingue i bisogni umani in tre categorie, in base alla loro necessità per la felicità:- Bisogni naturali e necessari: Essenziali per la sopravvivenza e il benessere del corpo, come mangiare, bere acqua, dormire, proteggersi dal freddo. Soddisfarli é fondamentale per la felicità.
- Bisogni naturali ma non necessari: Sono legati al piacere, ma non sono indispensabili, come bere vino invece di acqua, mangiare cibi raffinati. Possono essere appagati, ma non devono diventare indispensabili.
- Bisogni non naturali e non necessari: Sono desideri artificiali creati dalla società, come ricchezza, fama, potere. Chi li insegue finisce per vivere nell’angoscia, perché questi desideri non hanno mai un limite e portano solo insoddisfazione.