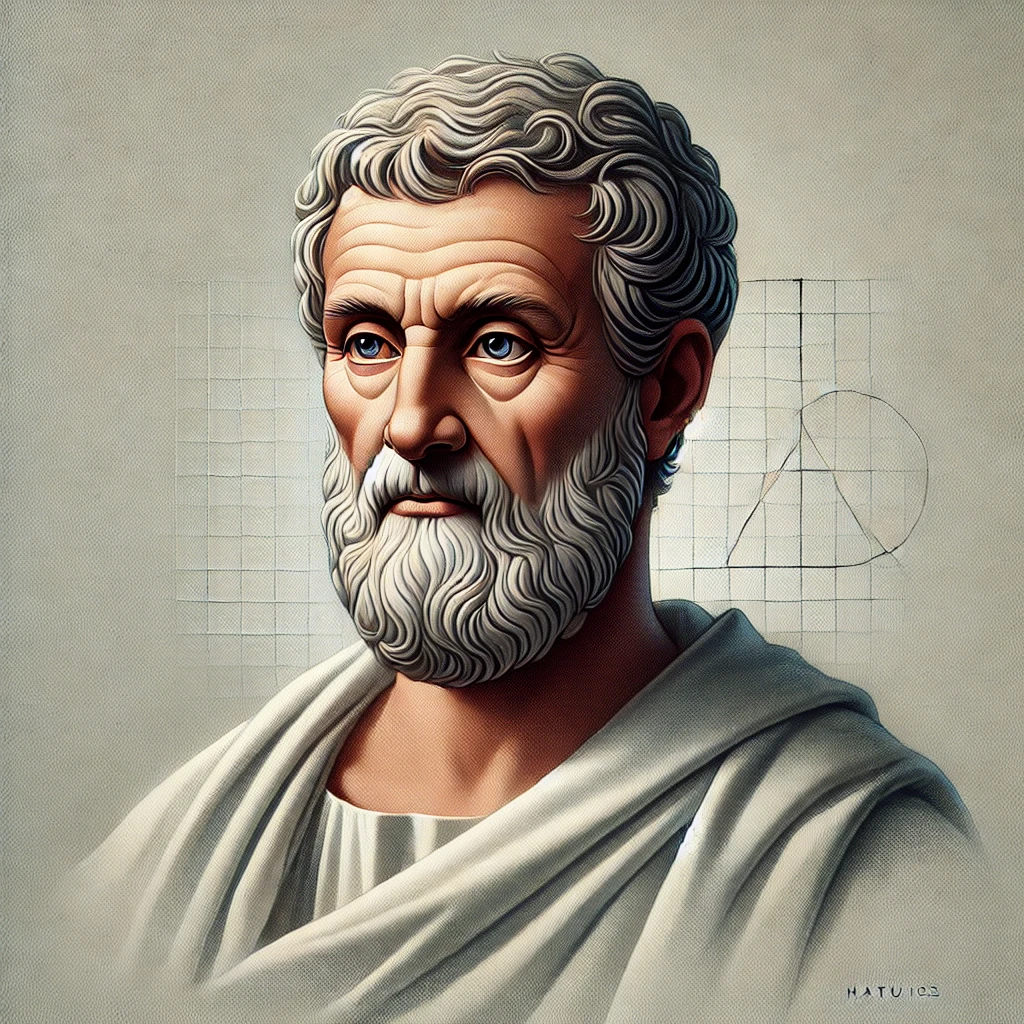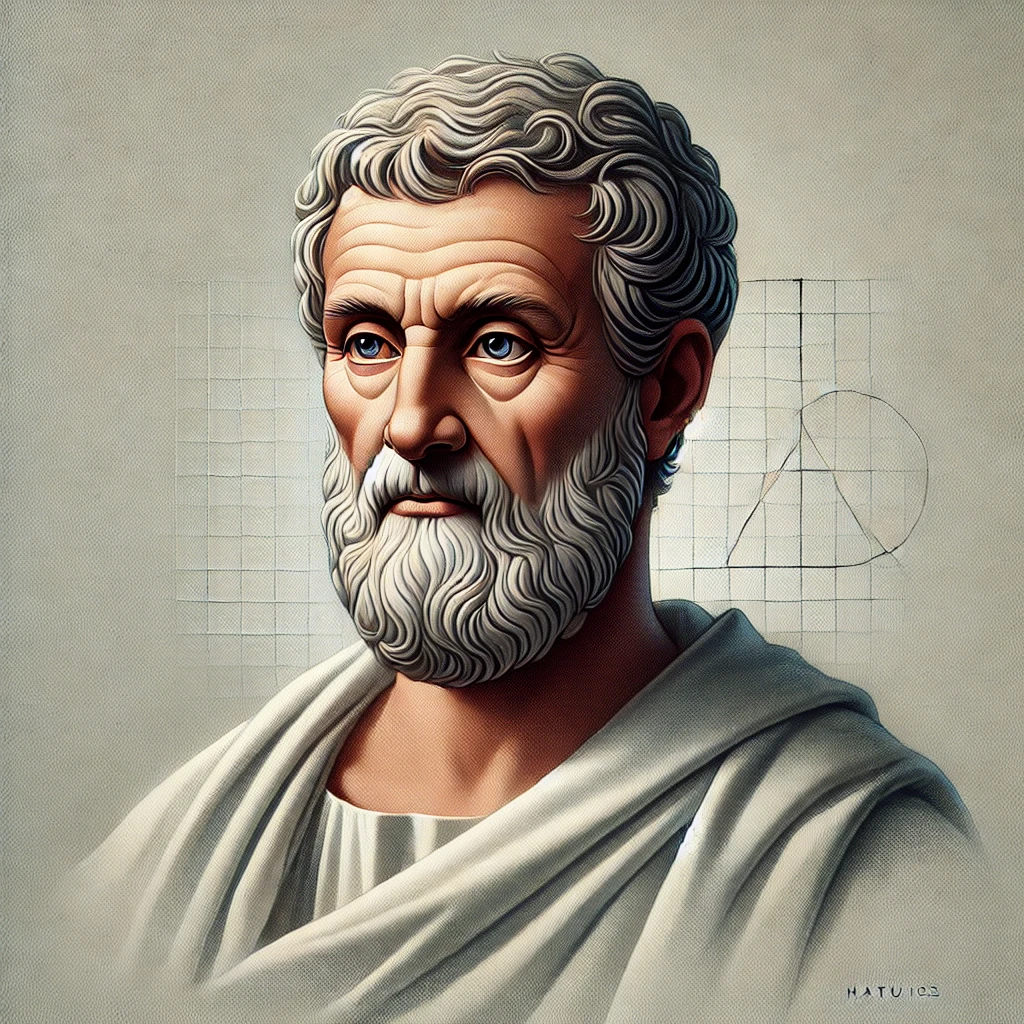
La scuola pitagorica rappresenta una delle tendenze filosofiche più importanti e longeve dell’antichità. Si trattava di una comunità strutturata secondo un modello scolastico con un maestro, Pitagora, e i suoi studenti, caratterizzata da un’impostazione chiusa ed esclusiva. Gli allievi venivano selezionati sulla base delle loro capacità intellettuali, ma, aspetto notevole per l’epoca, anche le donne potevano essere ammesse. La scuola trovava sede in Magna Grecia, nelle attuali regioni di Calabria e Basilicata, e per questo è considerata la prima scuola filosofica italica.
PITAGORA E STRUTTURA DELLA SCUOLA
Pitagora, originario dell’isola di Samo, fu probabilmente costretto a lasciare la sua terra per ragioni politiche. Si stabilì successivamente in Magna Grecia, dove fondò la scuola che porta il suo nome. Nonostante Pitagora sia il fondatore di questa tradizione, sappiamo poco di lui direttamente; ciò che conosciamo deriva principalmente dai testi pitagorici e dai suoi seguaci. La scuola distingueva gli studenti in due gruppi:- Gli acusmatici (da akúo, "ascoltare"), che potevano solo ascoltare gli insegnamenti senza intervenire;
- I matematici, che invece avevano il permesso di partecipare attivamente alle discussioni.
I NUMERI COME ARCHÈ
Come molti filosofi del loro tempo, i pitagorici si interrogarono sulla causa prima dell’universo e individuarono questa nella natura dei numeri. In questo contesto, i pitagorici rivoluzionarono la matematica, ponendola alla base non solo della conoscenza scientifica, ma anche della riflessione filosofica. Il sapere matematico, che Pitagora aveva probabilmente incontrato durante i suoi viaggi in Egitto, veniva dagli egiziani utilizzato a fini pratici, per risolvere problemi concreti. I pitagorici, invece, elevano la matematica ad archè, riconoscendo nei numeri il principio fondamentale che regola l’universo.Pur trattando i numeri come elementi astratti, i pitagorici li consideravano sia in senso aritmetico (studio dei numeri nella loro astrattezza) sia in senso geometrico o matematico (studio dei numeri nella loro proiezione spaziale). I numeri, dunque, non erano per loro infiniti: essi ritenevano che l’essere umano, in quanto finito, potesse comprendere solo ciò che è limitato. Tutto ciò che è illimitato veniva percepito come negativo, poiché sfuggiva alla conoscenza e, di conseguenza, al controllo.
Un aspetto peculiare del pensiero pitagorico era la distinzione tra:
- Numeri pari, considerati negativi perché potenzialmente illimitati. Vengono però considerati due numeri pari come sacri: il quattro e il dieci, poichè rappresentati secondo una figura sacra, il tetractys, rappresentazione chiusa derivata dalla somma spaziale dei primi quattro numeri.
- Numeri dispari, valutati positivamente perché la loro proiezione spaziale genera una figura chiusa, e quindi finita.
- Gnoseologico: serviva per comprendere le proporzioni della physis e, quindi, la sua essenza ordinata;
- Etico: educava l’uomo alla misura e all’ordine, contribuendo a raggiungere un equilibrio interiore.
ASPETTO ANTROPOLOGICO ED ETICO
Un aspetto significativo del pensiero pitagorico riguarda la metempsicosi, ovvero la trasmigrazione dell’anima da un corpo all’altro. Il termine deriva da psychè (ψυχή), che significa "soffio vitale" ed esprime l’essenza specifica di ciascun individuo. Secondo i pitagorici, l’anima (psychè) possiede una dimensione immortale, in contrasto con la mortalità del corpo (soma). Alla morte, dunque, l’anima si reincarna in un altro corpo, perpetuando un ciclo di vita e morte.Questo dualismo tra corpo e anima sottolinea una visione profondamente etica della vita: la reincarnazione non avviene casualmente, ma dipende dal grado di misura e virtù raggiunto dall’individuo durante la sua esistenza. Più un uomo vive secondo misura e ordine, maggiore sarà la probabilità di reincarnarsi in figure elevate, come filosofi o intellettuali. Al contrario, una vita disordinata e priva di virtù potrebbe portare alla reincarnazione in ruoli socialmente inferiori, come quello di schiavo.
La dottrina della metempsicosi presenta alcune similitudini con le credenze indiane, come il ciclo di reincarnazione legato al karma. Tuttavia, c'è una differenza fondamentale: mentre il pensiero indiano si sviluppa all'interno di una cornice religiosa, la riflessione pitagorica è interamente laica. Essa si fonda su un'analisi razionale e filosofica, piuttosto che su dogmi religiosi, ponendo al centro la ricerca dell’ordine e della virtù come strumenti per il miglioramento dell’anima.
In sintesi, la scuola pitagorica si distingue per la sua straordinaria capacità di fondere matematica, filosofia ed etica in un unico sistema, mostrando come lo studio dei numeri potesse rivelare tanto l’ordine dell’universo quanto quello dell’animo umano.