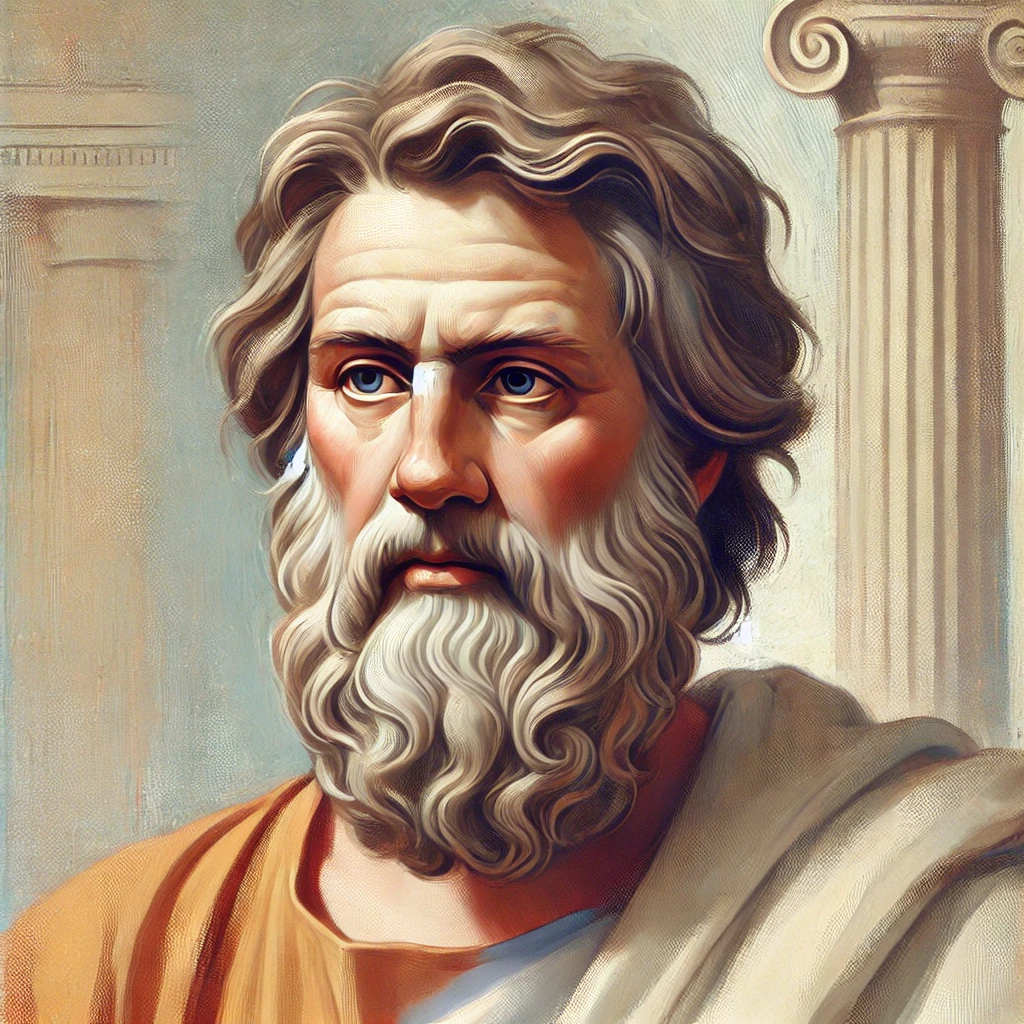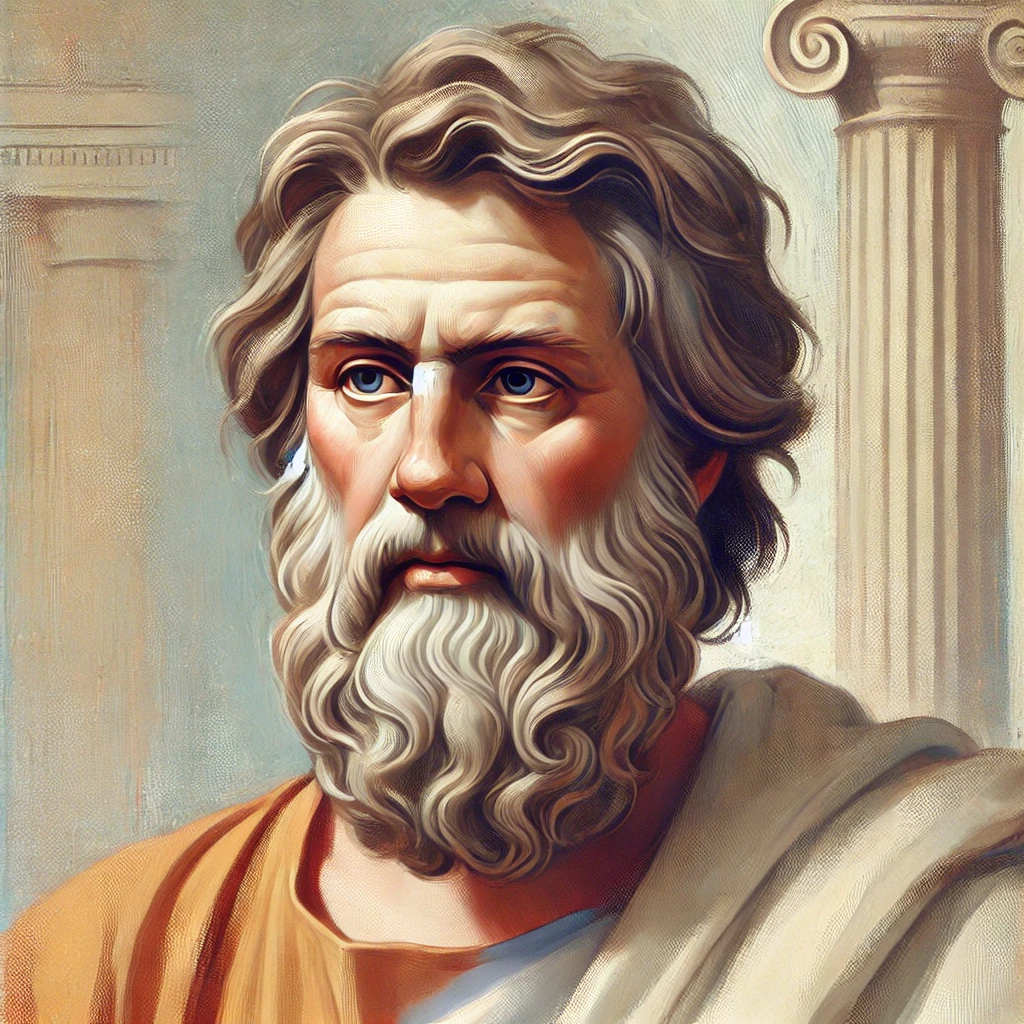
Platone è una delle figure più influenti della filosofia occidentale, il cui pensiero ha lasciato un'impronta
indelebile in molteplici ambiti, dalla metafisica alla politica, dall'etica alla teoria
della conoscenza. Allievo di Socrate e maestro di Aristotele, Platone ha elaborato una visione
filosofica articolata, fondata su una ricerca incessante della verità e sulla convinzione che la realtà
sensibile sia solo un'ombra del mondo delle Idee.
Oltre alla speculazione teoretica, Platone ha nutrito un profondo interesse per la politica, ritenendo
che il governo dovesse essere guidato dai filosofi, gli unici capaci di cogliere il Bene in sé. Tuttavia, il
suo rapporto con la politica non fu privo di delusioni: la condanna a morte di Socrate e l'esperienza
fallimentare a Siracusa segnarono profondamente la sua visione del governo e della giustizia.
PLATONE E LA POLITICA
Per nascita, Platone apparteneva a una famiglia aristocratica ateniese e, secondo le consuetudini del tempo, sarebbe stato destinato a ricoprire ruoli di governo. Tuttavia, la tragica fine di Socrate, accusato ingiustamente e condannato a morte nel 399 a.C., lo spinse a distaccarsi dalla politica attiva. Questo evento lo portò a interrogarsi profondamente sulle condizioni necessarie per la realizzazione di un governo giusto e sul ruolo della filosofia nella gestione della pólis (πόλις, città-stato).Convinto che la giustizia potesse essere realizzata solo in un sistema governato dalla razionalità e dalla conoscenza, Platone si recò a Siracusa, nella speranza di applicare le sue teorie politiche alla realtà. Tuttavia, i suoi tentativi si rivelarono vani e si conclusero con un esilio forzato. Questo insuccesso non lo distolse dalla riflessione politica, come testimonia la Settima Lettera, uno dei pochi testi in cui Platone scrive in prima persona. Qui egli rielabora criticamente la sua esperienza politica, ribadendo la difficoltà di tradurre in pratica le sue idee filosofiche.
STILE: DIALOGO, MISTICISMO ED IL RUOLO DEL MITO
A differenza di altri filosofi, Platone non espone il suo pensiero in forma saggistica, bensì attraverso il dialogo (διάλογος), un genere letterario che gli consente di presentare il confronto tra diverse prospettive e di stimolare nel lettore un’attiva partecipazione alla ricerca della verità. L’influenza di Socrate è evidente: la maieutica, ossia il metodo dialogico volto a far emergere la conoscenza latente nell’interlocutore, è una caratteristica essenziale della sua scrittura.Tuttavia, la filosofia platonica non si esaurisce nei dialoghi. Nella Settima Lettera, Platone fa riferimento alle dottrine non scritte (ἄγραφα δόγματα), concetti filosofici che non possono essere trasmessi attraverso il linguaggio ordinario. Queste conoscenze, di natura superiore, sono accessibili solo attraverso un’esperienza diretta e contemplativa.
Uno degli aspetti più profondi della filosofia platonica riguarda inoltre la natura della conoscenza. Egli distingue tra il sapere sensibile, basato sull’esperienza empirica, e il sapere intellettuale, che permette di cogliere le Idee eterne e immutabili. Tuttavia, vi è un livello ancora più alto di conoscenza, di natura mistica, che non può essere appresa tramite il linguaggio o il ragionamento discorsivo.
Il termine mistico deriva dal verbo greco mýo (μύω), che significa "iniziare a una conoscenza nascosta". Nel pensiero platonico, questa esperienza conoscitiva viene caratterizzata dalla fusione tra soggetto e oggetto, poiché l’oggetto della conoscenza viene infinitamente superiore alle capacità cognitive umane. Per questo motivo, Platone afferma che l’Assoluto è espresso solo per negazione, in modo apofatico: si è dire cosa esso non è, ma non descriverlo positivamente.
Infine, un altro aspetto fondamentale della filosofia platonica è il ricorso al mito. Accanto al logos, Platone attribuisce un ruolo centrale al mito (μῦθος), che utilizza nei suoi dialoghi per esprimere concetti altrimenti inesprimibili. Molti suoi scritti, come il Fedro e il Timeo, contengono narrazioni mitiche volte a trasmettere verità profonde attraverso immagini e simboli.
Il mito, per Platone, non è semplice fantasia, ma uno strumento filosofico in grado di avvicinare l’anima alla conoscenza del vero. Esso si rende necessario perché vi sono domande a cui la pura razionalità non può dare risposta: questioni sull’origine del mondo, sull’immortalità dell’anima e sulla natura del divino.
AFFINITÀ E DIFFERENZE CON SOCRATE
Pur essendo allievo di Socrate, Platone non si limita a proseguire il pensiero del maestro, ma sviluppa una filosofia originale e strutturata. Se in Socrate il metodo dialogico era principalmente volto a smascherare le false certezze, Platone lo utilizza per costruire un sistema teorico solido, fondato sulla distinzione tra il mondo sensibile e il mondo intellegibile.Un elemento comune tra i due pensatori è l’uso dell’ironia, ossia una strategia di dissimulazione attraverso cui si invita l’interlocutore a mettere in discussione le proprie convinzioni. Tuttavia, mentre in Socrate essa si manifesta nella forma della confutazione, in Platone diventa uno strumento pedagogico per guidare il lettore verso la verità.